Logbook
Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

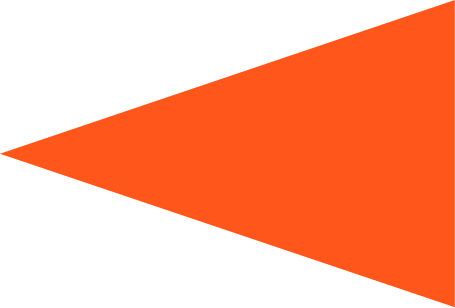
Giorgio Strehler: cuore, pancia, cervello e sesso
È sempre l’ora di un centenario: l’anno scorso è stato ricordato Federico Fellini, mentre Gianrico Tedeschi e Franca Valeri ci hanno pensato da soli a soffiare sulle candeline del 2020; nel 2022 ci saranno Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi e nel corso del 2021 ci sono anniversari intestati a grandi personalità come Leonardo Sciascia, Gianni Agnelli, Alida Valli, Nino Manfredi. E il 14 agosto sarà il turno di uno dei più grandi registi del mondo, Giorgio Strehler, leonino come la sua data di nascita. Con lui, fondatore con Paolo Grassi nel 1947 del Piccolo Teatro di Milano, il teatro è divenuto pubblico, d’arte, per tutti, con spettacoli memorabili in tutto il mondo: Shakespeare, Brecht, Pirandello, Goldoni, Čechov, oggi li vediamo con i suoi occhi. Con lui, Luchino Visconti, Orazio Costa, Luigi Squarzina, Massimo Castri, e poi Luca Ronconi — un genio che ha diretto il Piccolo per vent’anni nei modi opposti al fondatore — abbiamo scoperto quanto è importante il regista.
A cent’anni dalla nascita triestina e a 23 dalla morte la notte di Natale del 1997 a Lugano, mentre sono già cominciate le celebrazioni e stanno per uscire due volumi — 20 lezioni su Giorgio Strehler di Alberto Bentoglio (Cue Press) e Il ragazzo di Trieste di Cristina Battocletti (La nave di Teseo) — Andrea Jonasson, grande attrice di formazione tedesca, moglie primadonna di Strehler, lo ricorda in esclusiva per «la Lettura».
Andrea, come passerà il 14 agosto 2021?
Parlando con lui, con Giorgio, come faccio tutti i giorni, con un bel mazzo di gigli bianchi e margherite che gli piacevano tanto.
Che pensieri le suggerisce la data?
Che Giorgio odiava invecchiare: voglio vivere in piena forma fisica e artistica, non su una sedia, diceva. Non desiderava arrivare a cent’anni, magari sarebbe diventato un grande saggio, un uomo del mare fermo su una barca.
Strehler è stato dimenticato?
Temo di sì, un po’. I tempi sono molto cambiati. Da anni non lavoro in Italia e quindi non lo so, ma qui in Austria si sente parlare poco di lui, a meno che non lo faccia io.
Qual è stato il suo più grande insegnamento?
Libera la tua fantasia, sbaglia, continua a dubitare, usa anche la leggerezza. Difficile raccontare un genio.
Che debito abbiamo con lui?
Faceva un teatro comprensibile a tutti: una sera il fisico Carlo Rubbia, il Premio Nobel, ci disse che vedere le prove di Strehler era meglio che guardare le stelle.
Com’è stato vivere con lui?
Miracoloso, bellissimo, difficile per le rinunce, ma la vita con lui era sempre magica.
I momenti più magici?
Tutti erano ‘più’. Era meraviglioso vivere con un grande, temevo di non essere alla sua altezza. Era magia vedere le sue prove, era un’avventura recitare diretta da lui.
Come fu il vostro incontro a Vienna nel 1972?
Recitavo Botho Strauss e Giorgio era venuto per il cast del Gioco dei potenti. Mi fece chiamare, scesi la scala per raggiungerlo e si complimentò per il vestito nero: guai, disse, mettere un abito a fiorellini o le scarpe rosse, non saranno mai in scena con me. Poi raccontò in due minuti chi sarei stata nello spettacolo, la regina Margherita, e rimasi senza parole. Mi affidò la parte e se ne andò.
Quant’è stato brutto l’ultimo periodo di lontananza?
Nessun commento. Posso solo dire che nessuno è incolpevole.
Riusciva a sdoppiare il ruolo di moglie e attrice?
Assolutamente. Lui si scusava se qualche volta era duro, durissimo, diceva che lo faceva per gli altri colleghi, voleva far capire che non faceva differenze. Era severo ma sempre e solo per amore. Amava gli attori, non era un tiranno. Aveva il nervosismo di van Gogh quando non trovava il giallo giusto per i suoi fiori; allo stesso modo Giorgio cercava una luce, un’intonazione, una pausa.
Che spettacolo ricorda con nostalgia?
Il gioco dei potenti a Salisburgo perché alle prove un giorno si mise alle mie spalle di regina e mi disse: ich liebe dich, ti amo, ti amo, ti amo. Credevo di svenire.
In che cosa non è stato capito?
Era comprensibile per tutti. E tutti l’hanno capito.
Chi sono i suoi allievi?
Sono morti, quelli bravissimi come Patrice Chèreau e gli altri. C’è solo Lluís Pasqual suo allievo, ma credo che oggi nessuno dica che vuole fare uno spettacolo alla Strehler. Penso che ci sia ancora molta invidia.
Quale fu la serata peggiore vissuta con lui?
Quando ricevette un avviso di garanzia, una questione burocratica sui finanziamenti del teatro. Era ingiusto, infatti fu assolto, ma fu terribile. Lui voleva morire: la notte in cui portarono l’avviso eravamo tornati da una serata per i Mémoires di Goldoni a Pavia con laurea…
E quella migliore?
Ma caro… Sono tante le serate migliori. Per me la prima dell’Anima buona di Sezuan, in italiano, ed era una battaglia vinta. E quando, dopo le prime, si tornava a casa, aprivamo lo champagne e lui diceva: glielo abbiamo messo nel c… anche questa volta. Ma no, non scriverlo.
Useremo i puntini… E le gite in mare?
Dopo i debutti si chiudeva come un orso in una tana in silenzio, al buio, anche depresso. Poi si andava al mare e ci saltava dentro come un pesce: un giorno avevamo in barca un modellino dei Mémoires di Goldoni con piccole candeline accese, e a un certo punto prese fuoco. Io ci buttai il mare per spegnerlo ma rimase un modellino incenerito: ora so — mi disse — come inizio lo spettacolo, con Goldoni vecchio che guarda lo scempio del teatro che andò davvero a fuoco.
Cosa le sarebbe piaciuto interpretare con lui?
Prima della terribile notte del 1997 mi disse: finito il Così fan tutte, ti giuro che torno a Milano, e iniziamo a fare un Antonio e Cleopatra vecchi, anche se notai che avevo 22 anni meno di lui. Se ne andò a Lugano perché io in casa avevo le mie sorelle per Natale e non ci stavamo tutti. Disse: torno dopodomani e parliamo del futuro.
Che cosa le ha mostrato di Milano?
Aveva poco tempo, studiava o provava, ma mi ha mostrato la bellezza dei giardini di Milano, che non è affatto una città grigia. E mi ha portato a vedere L’ultima cena di Leonardo, una sera, noi, solo noi.
E poi c’era Paolo Grassi…
L’ho sempre visto insieme alla moglie Nina Vinchi, la segretaria generale del Piccolo, si dicevano cose carine tra loro. Giorgio lo prendeva in giro per l’erre moscia.
Come giudica i vent’anni di Ronconi al Piccolo?
Era un grande, ma l’opposto totale di Strehler, perché Luca era un intellettuale, un po’ cervellotico, mentre Giorgio sosteneva che un regista deve avere cuore, pancia, cervello e sesso.
Chi sono i suoi amici del Piccolo?
Non ci recito da dieci anni, ormai ho pochi contatti, i grandi amici sono morti; sento ogni tanto Ornella Vanoni che mi diverte, Giulia Lazzarini, Franca Nuti e Giancarlo Dettori…
Chi l’ha avvertita della disgrazia la notte di Natale?
Mamma mia. Parlare di questo mi fa troppo male. Non posso. Fu l’autista che mi suonò alla porta di via Medici, ma davvero ricordare fa troppo male. Pensai che non era vero, che era uno sbaglio, perché se invece fosse stato così, allora la mia vita sarebbe finita. È stato così…
Come ricorda i funerali di Strehler con la folla, quasi l’isteria degna di Rodolfo Valentino?
Vero. Ero sotto choc. Ma sentivo un amore immenso da ogni balcone, da ogni finestra; era tutto incredibile.
Come vivrebbe oggi Giorgio?
Male. Malissimo. Non lo vedo alle prese con il digitale, un gigante come lui avrebbe potuto stare a riposo e da solo? Forse si sarebbe messo a scrivere, ma diceva sempre che non voleva scrivere di sé perché non sapeva spiegare il segreto dell’ispirazione delle sue regie. Di sicuro amava la platea piena e non una sala virtuale.
Quando le viene in mente Strehler?
Sempre e soprattutto quando mi annoio a teatro, cioè quasi sempre. Da mattina a notte mi è sempre accanto, gli parlo, con lui non mi sono mai annoiata. Lo penso con gratitudine, per avermi regalato 24 anni di avventure di teatro con pazienza e amore.
Lo sogna?
Ogni tanto, ed è sempre agile, di corsa, bello, scappa da una parte all’altra come da vivo. Una notte ho sognato che stavo entrando in un aereo con l’urna delle sue ceneri ma dentro c’era il profumo che usava lui alla lavanda. Giorgio alle mia spalle mi diceva: sono qui.
Cosa rimpiangeva di non aver fatto in teatro?
L’Amleto. Voleva farlo con lo spettro del padre dentro il corpo di Amleto, come uno sdoppiamento, un dialogo con sé stesso. E poi naturalmente la vita di Goldoni.
Esiste un nome per il suo stile?
Teatro umano, comprensibile a tutti, moderno e antico. Diceva sempre di voler essere fedele ai suoi autori.
Com’è cambiato il teatro in questi anni?
Oggi il teatro è spesso noioso, tradisce invece molto gli autori, il regista stravolge come m’è capitato vedere con Strindberg e Ibsen. E si usano troppi video.
Giorgio era davvero un monaco del palcoscenico?
Direi di sì. Si chiudeva nel buio, pensando e soffrendo. Ed era davvero un monaco, viveva una grande solitudine dal fondo della quale poi creava, in cui s’ispirava.
A chi voleva bene?
A tutti i suoi attori, ai tecnici, a tutti, compresi i pessimi. Voleva bene al mondo. Questo esprimeva con il suo teatro che era un atto d’amore.
Il suo rapporto con le donne?
Adorava le donne, era innamorato, era un uomo vanitoso, amava l’idea che le donne lo amassero. Io non ero troppo gelosa, ero orgogliosa perché mi piaceva avere un uomo che affascinava le altre.
Qual era l’arma di seduzione di Strehler?
L’arma? La vivace saggezza, l’umore, il temperamento, il suo buon profumo selvatico al rosmarino oggi scomparso.
Il più grande rimpianto?
Non avere avuto figli, lui diceva che il figlio era il Piccolo. Se avessimo avuto una figlia Giorgio avrebbe voluto chiamarla Ombra, che oggi è la mia cagnolina.
Titina: l’artefice magica dei De Filippo
«Sebbene Filumena Marturano sia stata allestita in molti teatri stranieri e abbia avuto in Italia altre non meno brave attrici, la vera immagine della protagonista rimane indissolubilmente legata alla sua prima, grande interprete che si preoccupò di rendere la persona di Filumena creatura di vita, personaggio reale ed umano, contribuendo a personificare sulla scena uno degli aspetti più dolenti di una Napoli specchio di una società sciagurata di cui Eduardo aveva voluto ricordare resistenza».
Così conclude il capitolo dedicato all’analisi del personaggio più significativo e solidamente storicizzato del Teatro Napoletano della seconda metà del Novecento, di cui fu interprete Titina De Filippo. L’attrice – perno femminile del trio di famiglia con Eduardo e Peppino –, scomparsa prematuramente nel 1963, è oggetto di un lungo, approfondito studio firmato Simona Scattina, ricercatrice di Discipline dello Spettacolo presso il dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, pubblicato col titolo Titina De Filippo. L’Artefice magica presso l’Editrice Cue Press di Imola.
Il lavoro privilegia – tra le molte fonti consultate – la documentazione esistente presso la Biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli raccolta nel Fondo Carloni, di recente acquisizione, che comprende l’Archivio personale di Titina e di suo marito, l’attore Pietro Carloni. L’apertura alla consultazione di questo Fondo, reso pubblico per volontà dei familiari dell’attrice, colma la lacuna aperta dal ritiro dell’Archivio di Eduardo ad opera degli eredi del drammaturgo. Questo era stato a suo tempo ordinato e catalogato, così come è avvenuto per il materiale di Titina, da Claudio Novelli presso la Biblioteca di Storia Patria, poi trasferito presso la sezione Lucchesi Palli della Biblioteca Nazionale. Dopo la revoca dell’affido è ora di pertinenza della Fondazione De Filippo, ma non si hanno indicazioni su dove concretamente si trovi e sulla possibilità di consultazione da parte degli studiosi.
La ricostruzione della vita artistica e familiare di colei che, rispetto a Eduardo e Peppino ebbe – secondo quanto la loro mamma Luisa sovente diceva – ‘na furtuna piccerella, parte dalle prime esperienze avviate, come tradizione delle famiglie di teatranti, dai ruoli di adolescenti e quelli del teatro minore – il varietà, la sceneggiata – sino alla determinante esperienza nella storica compagnia Molinari, stabilmente operante tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento al Teatro Nuovo sopra Toledo, all’interno della quale per la prima volta si riunirono, ad iniziativa di Titina, i tre fratelli sotto l’etichetta «Ribalta gaia». Il filo conduttore che arriva in crescendo fino a Filumena, il «ruolo della vita» dell’attrice, passa attraverso i personaggi portati in scena nella prima e nella seconda fase dell’epopea teatrale dei De Filippo – prima in tre, poi in due -, quando cioè il «Teatro Umoristico» di Eduardo e Peppino, ma anche di Titina – autrice di commedie di successo, come Quaranta, ma non li dimostra -, divenne «Il Teatro di Eduardo» per l’affermazione completa dell’autore e della sua drammaturgia. Personaggi brillanti, umoristici, patetici, in una recitazione talmente fusa con i fratelli, da far dire a qualcuno che quei tre fenomeni fossero in realtà un attore solo. L’indagine riesce a recuperare l’unicità delle qualità attoriali di Titina, catalizzatrici di quella fusione, che esploderanno in Filumena proprio nell’incontrare un testo dichiaratamente scritto per lei, che la libera da quelle funzioni costantemente esercitate nel corso della carriera.
L’opera di Simona Scartina attraversa le testimonianze della critica, ma anche i rapporti personali e formativi dell’attrice con i fratelli, in modo particolare con Eduardo, la vita familiare e l’attività artistica complementare di Titina, il cinema, la pittura in collage, le sceneggiature dei film, le poesie. E, a differenza della maggioranza dei testi d’impostazione scientifica, il libro presenta una vena narrativa accorata e partecipe, anche attraverso la particolarità delle ricchissime note, niente affatto limitate alle precisazioni nozionistiche, ma che spaziano nell’approfondimento anche emotivo di circostanze e personaggi. Ed un preciso indice dei nomi guida facilmente la consultazione per una ripresa mirata del volume, che merita però di essere letto subito e di fila come un romanzo di vita vissuta nel magico e misterioso mondo del Teatro.
Il corso monografico in Statale diventa un libro per i 100 anni dalla nascita: «Il suo non fu il teatro del principe ma un teatro umano»
Il teatro? Uomini che si mettono insieme per salvarsi l’uno con l’altro. Parola di Giorgio Strehler, che torna protagonista nel centenario della nascita ben oltre il dovere della ricorrenza. Nelle aule universitarie, per esempio, che saranno anche virtuali a causa della pandemia, ma si scaldano comunque al cospetto del gigante della regia del Novecento. Certo, bisogna saperlo raccontare, Giorgio Strehler, a questi post-millennials che non hanno mai visto un suo spettacolo dal vivo. L’ha fatto Alberto Bentoglio, docente di storia del teatro in Statale, con un corso monografico, diventato anche un libro, 20 lezioni su Giorgio Strehler (Cue Press). Quattrocento pagine ad alta densità, volume corposo, strumento di studio, lettura godibilissima e bussola preziosa per orientarsi lungo le rotte di una smisurata avventura artistica.
Bentoglio, Strehler fa breccia anche nelle nuove generazioni?
Direi proprio di si. Questo libro raccoglie e amplia le lezioni che ho tenuto l’anno scorso, durante il primo lockdown che ci ha costretto a ripensare la didattica nella forma a distanza. Punitiva per certi versi, ma tutta da esplorare per altri. Con possibilità interessanti, per l’esempio l’integrazione sistematica di immagini e di video. Ha funzionato, gli studenti hanno risposto bene. Dirò di più. Ho avuto la netta impressione che Strehler abbia aiutato sia me sia loro a superare lo sconforto di questi mesi dandoci lo slancio per non soccombere alla desolazione.
Che cosa ha colpito di più i suoi studenti?
Credo la sua figura di personaggio scomodo, controcorrente. Lo spirito critico, l’irrequietezza che gli impediva di non accontentarsi spingendolo a cercare sempre qualcosa di più e di più difficile. Anche a costo di sbagliare. Si sono molto appassionati al Faust, cosa che non mi aspettavo. E invece in quell’avventura faticosissima e impossibile hanno trovato la lezione di un grande coraggio.
Personalità carismatica e tempestosa.
Una vera star. Per decenni protagonista della vita teatrale, culturale e politica, fotografatissimo, inseguito dalla stampa, anche quella rosa, in quanto uomo molto amato che amò molte donne. Fu al centro di polemiche, alcune davvero spiacevoli, ma non c’era giornale, dal più reazionario al più progressista, dal più colto al più frivolo, che non si occupasse di lui.
Contrariamente a Ronconi, Strehler era un grafomane. Ha lasciato centinaia di pagine di note di regia.
Una mole straordinaria di documenti, conservati nell’archivio storico del Piccolo, una risorsa preziosa. Strehler costruiva le sue visioni attraverso la scrittura. Scriveva molto bene, era affascinante, ancorato a una cultura vasta quanto solida. I suoi appunti e le sue note in parecchi casi sono dei veri e propri saggi, anche per quanto riguarda il teatro musicale. Le sue regie hanno spesso anticipato riletture critiche e teoriche di autori e opere. E andrebbero ripresi anche i suoi interventi politici. Quelli sull’Europa, soprattutto.
Cento anni dalla nascita. Come sfruttare questo anniversario?
Come un’occasione di approfondimento critico, bibliografico e scientifico. Credo che il punto sia interrogarsi non tanto su che cosa ha fatto Strehler ma su che cosa è rimasto del suo magistero. È ancora valido o è un’esperienza magnifica ma conclusa?.
Lei come risponde?
Il discorso è complesso, ma direi che la sua idea di rapporto con l’attore, quel modello didattico di educazione teatrale, oggi non sarebbe proponibile. Come è vero che, con il Novecento, possiamo considerare morto il teatro di regia dei grandi maestri.
Dunque che cosa resta di Strehler?
Il Piccolo e quell’idea di teatro come bene pubblico su cui l’ha fondato con Paolo Grassi. Per quell’idea ha combattuto da eroe del Novecento, senza mai ammainare la bandiera, da uomo uscito dalla Resistenza. Con risultati alterni, ma con grande coerenza, anche politica. Soprattutto etica. Il suo non è stato affatto il teatro del principe. Al contrario, un teatro umano.
Teatro di Rémi De Vos
«De Vos scrive testi scottanti sul declino dell’Occidente, sui problemi del lavoro, sulla violenza razzista, maschilista e omofobica e sulla disgregazione della coppia borghese […], passati al setaccio dell’umorismo e del grottesco, rivelando l’assurdità delle ideologie dominanti». Così Siro Ferrone introduce questa interessante raccolta di testi del francese Rémi De Vos, che vanta un lusinghiero successo internazionale (è tradotto in quindici lingue) a fronte di una assai modesta considerazione italiana.
Spetta al centro di produzione teatrale Pupi e Fresedde del Teatro Rifredi di Firenze la prima nazionale di Alpenstock (2005) per la regia di Angelo Savelli. Al centro della commedia, con cui si apre questa preziosa antologia, si pone una giovane coppia che abita nell’immaginario paese montano di Kirilo. L’armonia coniugale è prima turbata poi lacerata dall’arrivo di Yosip, l’immigrato di fantomatica nazionalità balcano-carpato-transilvana. Esplode il razzismo del marito, acceso sostenitore di valori di purezza di razza contaminati da maschilismo, che uccide l’intruso, forse metaforicamente perché il morto resuscita e, in modo grottesco e farsesco, si ripresenta più volte.
In Finché morte non ci separi (2003) risvolti altrettanto grotteschi e demenziali si intrecciano in una catena di sequenze narrative apparentemente lineari ma di fatto folli: un’urna funeraria, contenente le ceneri dell’anziana madre di Madelaine, cade dalle mani di Anne, amica del figlio Simon, e si rompe: per rimediare il disastro, il ragazzo dice alla madre di aver regalato il macabro oggetto alla ragazza come segno di fidanzamento e di aver disperso in contenuto in giardino. Manca l’elemento tragico, le tensioni sono aggirate da passaggi narrativi esilaranti che rendono i personaggi segni di esistenze assurde.
Una scrittura veloce e asciutta caratterizza Occidente (2004), testo presentato al pubblico italiano nella seconda edizione di Face à Face-Parole di Francia per scene d’Italia nel 2011 (regia di Silvie Susnel). Tra una coppia si anima un dialogo violento e nevrotico, pieno di reciproci insulti, per recuperare un’identità smarrita anche a livello erotico. Lui è uno «sporco fascista, alcolizzato e impotente» tanto che nelle sue parole si annidano evidenti veleni razziali contemporanei.
L’ossessione oscura è il tema dominante di Tre rotture (2012) vissute da una coppia in crisi in tre distinti quadri: nel primo, una sontuosa cena culmina con «io ti lascio» detto dalla moglie, cui segue la scena in cui la donna, legata ad una sedia, è imboccata dall’uomo con la carne del cane per poi rivelare i reciproci tradimento; nel secondo, il marito dichiara la propria omosessualità scoperta a seguito di un incontro con un pompiere conosciuto in palestra. L’inconsistenza interiore dei due personaggi produce un gesto violento, declinato in modo grottesco e surreale: l’uomo abbandonato versa un bidone di benzina addosso alla donna, accende e spegne più fiammiferi… Nel terzo quadro le relazioni familiari sono complicate da un figlio viziato e violento visto che «È lui a decidere», dice la donna, in merito alla ipotizzata separazione della coppia.
I personaggi di De Vos sono maniacali e ossessionati da paure che li rendono banali e soprattutto diffidenti. Si aggrappano, nel vuoto del pensiero, a soluzioni reazionarie con cui declinano la violenza fisica e verbale. Incarnano, in definitiva, molti individui d’oggi, planetari, catastrofici, assurdi.
Collegamenti
Parole che disvelano la verità: Barabba di Antonio Tarantino e il dialogo sulle Sette parole di Cristo
Dalla Russia con amore, i Maestri del Novecento
Grazie alla curatela di Fausto Malcovati, professore di Lingua e letteratura russa presso l’Università di Milano, Cue Press pubblica una preziosa collezione di autori russi da annoverare tra i maestri assoluti della prassi e della cultura teatrale. Altre due pubblicazioni si aggiungono qui alla copiosa raccolta, dedicati a Vsevolod Emilevic Mejerchol’d e a Stanislavskij.
Il primo, L’ottobre teatrale (1818-1939), è un volume pregevole, che raccoglie il contributo alla storia del teatro del Novecento, di uno dei maggiori teorici e rivoluzionari, Mejerchol’d, prima e dopo la sua adesione alle istanze della Rivoluzione d’Ottobre del 1917. Gli scritti teorici, suddivisi per sezioni tematiche (interventi politici, scritti sull’arte dell’attore, sulla formazione e sul ruolo del regista, scritti sulla struttura del teatro post-rivoluzionario) si affiancano ai materiali sugli spettacoli più noti da lui messi in scena. Si tratta di scritti per lo più inediti, in Italia, che, attraverso lo sguardo di Mejerchol’d generano un’emozionante cronaca in presa diretta su una rivoluzione non solo teatrale.
Il secondo libro, Stanislavskij alle prove, è il diario di scena dell’attore Vasilij Toporkov che, dal 1927, lavorò al Teatro d’Arte sotto la direzione del Maestro, prendendo parte a spettacoli quali I dissipatori di Kataev, Le anime morte di Gogol’, Tartufo di Molière. La descrizione del lavoro fatto dal regista sui testi, il resoconto delle sue parole filtrate dallo sguardo dell’attore, compongono un racconto avvincente del modo con cui Stanislavskij lavorava, da cui emerge il significato profondo dei concetti alla base del famoso ‘sistema’.
Memorie dalle megalopoli, come tessuto performativo
Avete mai provato, almeno una volta, la sensazione di immergervi fra le strade, nel sottosuolo di una città? Di una grande città, una di quelle con un numero di abitanti a sette o otto cifre, quelle città chiamate megalopoli nelle quali – secondo le proiezioni delle Nazioni Unite – entro il 2030 vivrà quasi il 9% della popolazione mondiale. Sono ambivalenti, le megalopoli: moltiplicatori di esperienze, acceleratori della memoria, ma anche luoghi di confusione, dove è facile disperdere il proprio sé, perdendosi. Instabili Vaganti, compagnia emiliana formata da Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno, ha fatto dell’esperienza del viaggio una cifra del proprio percorso artistico. Viaggio attraverso il mondo, dalla Corea all’India, dal Nord Europa al Messico, al Cile, all’Italia, raccogliendo esperienze, conservate nei racconti prodotti dal lavoro della compagnia insieme ad artisti e performer incontrati nei luoghi visitati. La forma è sostanza. Il metodo di ricerca fornisce il colore, il sapore, i suoni al lavoro stesso. Global City racconta un frammento del percorso di Instabili Vaganti durato circa sette anni, dalla formulazione del progetto Megalopolis (2012) alla sua evoluzione in Global City, spettacolo andato in scena al Nazionale di Genova a ottobre 2019. Compreso tra queste due date il viaggio e le sue tappe. Città del Messico, Montevideo e Malmö, Tampico e Calcutta, Shangai e Tehran, Seoul e Katmandu, ma anche i ritorni a casa a Napoli, Bologna, Cascina, in Basilicata, accumulando esperienze grazie al lavoro condiviso, per raccontare lo smarrimento e le opportunità, le contraddizioni e i luoghi comuni, lo sporco e il sommerso, le luci e i rumori che costituiscono l’aspetto quotidiano delle megalopoli, anche in contrasto stridente con la dimensione piccola e lenta dei paesi. Luoghi di disumanizzazione, distopici, contro eutopie, luoghi buoni dove un equilibrio è possibile. Nel volume confluiscono i molti materiali, riflessioni e note di regia, foto e diari di questo viaggio, coagulati alla fine nel testo-partitura dello spettacolo andato in scena a Genova, una drammaturgia mobile e stratificata come le mappe urbane.
Totò, lo straordinario attore marionetta
Un volto irregolare, una mimica facciale e una disarticolazione corporea fuori del comune, «un marionettismo capace di tutte le bizzarrie» hanno reso Totò icona immortale del cinema italiano. Ma il Principe della Risata mosse i primi passi da attore recitando a Napoli nelle farse a soggetto della tradizione comica tardo ottocentesca, tramandata dalle famiglie d’arte e basata quasi completamente sull’improvvisazione, una pratica teatrale che affinò ininterrottamente anche quando si misurò con le nuove forme dello spettacolo. La bella antologia Il teatro di Totò. 1932-46, curata da Goffredo Fofi e pubblicata alla fine del 2020 da Cue Press, raccoglie esilaranti sketch scritti da Totò e da lui interpretati nei varietà e nelle riviste: una preziosa raccolta di testi inediti che, sebbene poco più che canovacci, chiaramente funzionali all’inventiva e alla dilatazione mimica e verbale dell’attore, documentano, almeno in parte, il momento più autentico della sua comicità, successivamente arginata e normalizzata dal cinema. Un’arte scenica purtroppo verificabile solo nelle testimonianze di chi ha avuto la fortuna di vederlo recitare in teatro. Anche i temi presenti in questi testi, come la mancanza di danaro e la fame (La scampagnata), i travestimenti e gli scambi di persona (Totò divo del cinema), la lotta dell’uomo qualunque contro l’autorità (L’onorevole in vagone letto), per fare solamente alcuni esempi, se da un lato indicano il progressivo passaggio ad argomenti sempre più vicini alla cronaca, accompagnata da intenti di satira politica e sociale, dall’altro evidenziano un’essenzialità drammaturgica che prefigura la singolare capacità dell’attore di farsi scrittura scenica, oltre a sottolineare quella vena corrosiva e dissacrante che caratterizzerà il meglio delle sue interpretazioni cinematografiche.
Vsevolod Ėmil’evič Mejerchol’d, 33 svenimenti
Tra il 1934 e il 1935, pur all’inizio del terribile periodo della persecuzione staliniana, Mejerchol’d torna alla leggerezza del teatro di Anton Čechov, mettendo in scena tre brevi atti unici (L’anniversario, La domanda di matrimonio e L’orso): sarà l’ultimo spettacolo prima del suo assassinio.
Accomunati dal leitmotiv dello svenimento (di cui Mejerchol’d ne conta appunto trentatré), questi tre testi di mirabile comicità e dinamismo divengono nuove occasioni per veicolare un credo teatrale in cui attore, scena e testo creano un’armonica unione nella recitazione sul palcoscenico.
Il presente volume alterna gli atti unici di Čechov ai resoconti delle prove di Mejerchol’d con i suoi allievi, appunti che ci consegnano la voce e gli insegnamenti di uno dei più influenti registi teatrali del Novecento.
Collegamenti








