Logbook
Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

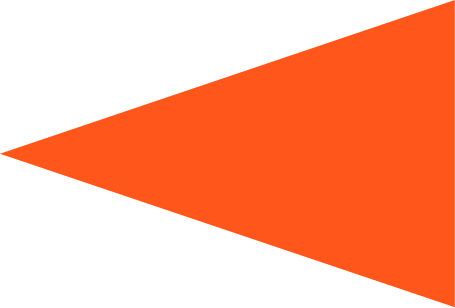
Le Lettere di Strindberg. A nudo il cuore del genio.
August Strindberg ha regalato alla storia della letteratura opere teatrali quali ad esempio Signorina Giulia, Un sogno, Danza di morte e Sonata di spettri, che hanno riscritto e riposizionato i confini e gli ambiti dell’espressione teatrale, tracciando il solco nel quale si sono poi inserite tutte le più importanti avanguardie del Novecento, in particolare l’espressionismo e il ‘teatro della crudeltà’ di Artaud, che non a caso fu un suo appassionato ammiratore nonché regista di alcuni suoi testi scenici.
Le opere di Strindberg, che fu anche un prolifico narratore (basti ricordare lo straordinario romanzo La sala rossa, l’autobiografia in quattro volumi Il figlio della serva e i sulfurei Autodifesa di un folle e Inferno), hanno inoltre contribuito a mutare la percezione che l’essere umano ha di se stesso, molto prima che la psicanalisi e la cosiddetta letteratura della crisi, nei primi decenni del Novecento, mostrassero fino a che punto l’io umanistico fosse in ultima analisi una mera entità volatile e provvisoria.
Genio in chiaroscuro
Ma con Strindberg, come con tutti gli scrittori scopertamente autobiografici, bisogna stare molto attenti, perché la vita riflessa nell’opera è in larga parte frutto di una reinvenzione che, secondo le parole dello stesso Strindberg, costruisce un mosaico con i tasselli forniti dalla vita e quindi «è opera di poesia e non menzogna», ma nemmeno una verità incondizionata. La verità vera di Strindberg – nella misura in cui di una vita umana possa esistere una verità vera – è invece contenuta nel suo vasto carteggio, del quale viene ora riproposta un’ampia scelta in versione italiana in un volume della collana I classici delle edizioni Cue Press (con l’aggiunta di un ricco apparato iconografico) a cura dello scandinavista Franco Perrelli.
È qui, infatti, in queste densissime pagine, che Strindberg si racconta in maniera diretta e senza reinvenzioni, dagli esordi al lungo esilio volontario in Svizzera, dall’esaltazione per Nietzsche alla contrastata amicizia con Edvard Munch, dagli anni di profonda crisi a Parigi fino al ritorno in Svezia e alla tarda utopia del Teatro Intimo.
Una verità dialettica
Nelle lettere di Strindberg ci sono tre matrimoni falliti, peripezie personali, fumisterie varie, perfino miserie, repentine accensioni e abissali disincanti, ma anche (o forse conseguentemente) una concezione assolutamente innovativa dei rapporti tra gli uomini e una lettura profondissima delle finzioni sociali.
Genio assoluto ma anche personaggio con molte ombre e poche luci (almeno secondo le ordinarie categorie di giudizio), Strindberg visse infatti una vita travagliata, sempre sul confine tra normalità e follia, ebbe tre mogli che trattò malissimo (e che a loro volta si servirono del suo sconfinato talento per scopi non propriamente nobilissimi), civettò con l’anarchismo e altri movimenti rivoluzionari e infine fu un inguaribile misogino. Questo, almeno, è quanto dice la vulgata, ma la verità che emerge dal carteggio è molto più sfumata, screziata e ricca di risvolti. E soprattutto è una verità dialettica, fondata sugli opposti.
Folle, certo, ma insieme lucidissimo (e cioè di una follia controllata e resa produttiva), razionalista e mistico, misogino e insieme adoratore dell’eterno femminino, quasi sempre eccessivo e sopra le righe ma incredibilmente profetico: Strindberg (che tra l’altro fu anche un discreto pittore) è stato davvero un genio universale, esattamente come il suo predecessore e modello Goethe, ma senza l’idea della continuità espressa nel ‘muori e diventa’ dello stesso Goethe. Ogni volta che è ‘morto’, infatti, Strindberg è ‘diventato’ un altro descrivendosi come dall’esterno, ed è proprio questa sorta di sofferto straniamento, che nel carteggio si profila con estrema chiarezza, a renderlo così vicino e attuale.
Itinerario indimenticabile nel teatro italiano fra Ottocento e Novecento. Quando il ‘fenomeno’ Duse diventò leggenda
Cesare Molinari scrisse L’attrice divina nel 1985, anticipando il volume, più volte annunziato, di Gerardo Guerrieri che, da circa un trentennio, aveva svolto una serie di ricerche attorno all’attrice, culminate in alcuni saggi, in uno spettacolo teatrale: Immagini e tempi di Eleonora Duse, e in una monografia pubblicata nei Quaderni del Piccolo Teatro nel 1962. Solo dopo la sua morte, Lina Vito curò, per Bulzoni, raccogliendoli in un volume, i nove saggi scritti da Guerrieri.
Per chi voglia addentrarsi, però, nella conoscenza della Duse, ovvero del personaggio che sconvolse la storia dell’attore di fine Ottocento, non può fare a meno dei testimoni che le sono stati accanto, di Luigi Rasi, a cui dobbiamo la prima biografia che arriva al 1901, anno di pubblicazione del suo libro, di Eduard Schneider che scrisse sull’ultima Duse (1924), di Olga Signorelli che si sforzò di offrire una biografia completa (1938), di Silvio D’Amico che le dedicò tre capitoletti in Il tramonto del grande attore. Cito ancora, per ricordare il mio maestro: La Duse di Mario Apollonio (1948), che stava per essere rappresentata al Piccolo Teatro, cosa che non avvenne dopo tanto tergiversare con Paolo Grassi.
Perché questo preambolo? Perché Cesare Molinari utilizza la biografia come pretesto, essendo il suo studio proiettato oltre, ovvero verso quanto era accaduto nel teatro italiano fra due secoli, che è il sottotitolo di L’attrice divina, ristampato da Mattia Visani per Cue Press, con introduzione di Elena Bucci.
Il percorso storico di Molinari, che svolge in sette capitoli, parte da Napoli, dal 1879, dopo l’avvento della Sinistra al potere, caratterizzato dal trauma dell’unificazione, dalla miseria e di come i teatri proliferassero in un momento in cui c’era bisogno di ben altro.
In questo scorcio di secolo, iniziarono a imporsi le prime attrici, dopo il dominio dei mattatori. Tra queste, le più famose erano state: Adelaide Tessero, Virginia Marini, Giacinta Pezzana e la Duse che, proprio in questo anno, per averla in Compagnia con la Pezzana, furono versati, dall’impresario, cinquemila lire di penale, per poter sciogliere un contratto firmato precedentemente dalla Duse. Sempre da questa data, tutti i giornali cominciarono a parlare di lei con le firme di Cafiero (con cui la Duse ebbe una relazione), di Bracco, della Serao, di Boutet, che fecero ricorso a molteplici aggettivi sulla sua recitazione: attrice moderna, versatile, sublime, ecc.
Molinari accompagna il lettore in un itinerario indimenticabile, utilizzando la Duse come compagna di viaggio all’interno della nostra drammaturgia, un po’ avvilente rispetto a quella francese o a quella nordica, di un Ibsen, per esempio, ma anche all’interno delle Compagnie Stabili (stanziali), di quelle itineranti, avendo a che fare con agenti parassiti e speculatori. Non manca un viaggio all’interno della terminologia teatrale del tempo, per sottolineare la distinzione tra il ‘ruolo’ e la ‘parte’, e, soprattutto tra i ‘generi’, col passaggio dalla tragedia storica al dramma borghese, a quello popolare, fino al teatro di poesia di D’Annunzio. Il tutto attraverso il ‘fenomeno’ Duse che, nel tempo, diventerà leggenda, come ebbe a scrivere Reinhardt: «Aveva cinquant’anni ed era già leggenda».
Molinari indaga il repertorio tra i due secoli presi in esame, che vedeva spesso la Duse a disagio dinanzi a commedie di nessun valore, che entravano in repertorio grazie alle sue interpretazioni, delle quali Molinari ricostruisce le metodologie, lo stile, i canoni, l’arte recitativa. Egli si sofferma ancora sul rapporto tra impresari e organizzatori, sul sodalizio con Boito, sull’incontro artistico con D’Annunzio, sulla polemica tra lei e il poeta, in occasione della pubblicazione del romanzo Il fuoco, dove veniva raccontata la loro storia d’amore senza veli e, infine, sui ruoli di madre che interpretò nell’ultima parte della sua carriera.
Dicevo che la Duse è un pretesto, dato che lo storico Molinari intende ritrarre la vita teatrale a cavallo tra Ottocento e Novecento, quando il teatro, da solo, copriva il fabbisogno di una intera popolazione, quando le esibizioni erano appartenute al mattatore, una specie di performer ante litteram.
Ci informa inoltre che in Italia, con 29 milioni di abitanti, dopo l’unità, venivano registrati 1055 teatri in 775 Comuni, e che gli affari si aggiravano sui sette milioni di lire, grazie a 150 Compagnie drammatiche, ospitate nei teatri municipali, ma anche in Accademie private sparse per la penisola.
Ogni capitolo è seguito da una bibliografia e da una serie di immagini dell’attrice. Elena Bucci, nella sua accorata prefazione, fa notare quanto sia, oggi, impossibile conoscere la vera autenticità della Duse, pur essendo stata «il romanzo di un’epoca», convinta che i miti non siano altro che racconti straordinari.
Collegamenti
I maestri di domani in viaggio verso il futuro
Indimenticabile, per chi lo ha vissuto, il corposo progetto Futuri Maestri del Teatro dell’Argine, che racchiudeva l’«epica, folle e utopica» (citando A. Paolucci) impresa, durata due anni dello spettacolo omonimo che ha ospitato tra il 3 e il 10 giugno 2017 all’Arena del Sole di Bologna mille bambini, bambine, adolescenti, e un ‘maestro del nostro tempo’ diverso ogni sera.
Sarebbe riduttivo definire questo volume un semplice ‘copione’, sia per l’irriproducibilità della performance – consapevolezza che dall’inizio ha affiancato la coraggiosa e ostinata compagnia di San Lazzaro di Savena (Bo) – sia per la copiosità delle didascalie che accompagnano scene e battute dei giovani attori.
Come una sorta di guida dantesca nel viaggio che passa attraverso un Inferno metaforico, paesaggio realmente presente tra quelli evocati, la voce onnisciente delle didascalie narra i simboli nello spazio, i movimenti dei servi di scena e degli attori, alla ricerca di un luogo in cui essere liberi di esprimersi e incontrare gli adulti che potrebbero essere i loro maestri, per tramandare a loro volta, ai ‘futuri maestri’ el domani, l’immagine di un mondo migliore.
La pubblicazione comprende le Nove lettere ai viaggiatori dei maestri partecipanti (Simonetta Agnello Hornby, Paola Caridi, Ignazio De Francisci, Alessandro Frigiola, Giuseppe La Rosa, Loredana Lipperini, Yusra Mardini, Alessandra Morelli, Francesco Piccolo) e gli interventi di Nicola Bonazzi, di Andrea Paolucci – che con Vincenzo Picone e Mattia De Luca hanno coordinato il progetto drammaturgico – e degli studiosi Gerardo Guccini e Federica Zanetti.
Bergman, uno specchio in bianco e nero
La bella immagine di copertina mostra un giovane Bergman in posa da divo di Hollywood, come il fotogramma in bianco e nero di un film di Frank Capra. Lui, che più lontano dalla mitologia del cinema americano del dopoguerra non poteva essere, profondamente radicato nel suo ambiente nord-europeo e nella cultura scandinava da cui traeva linfa e nutrimento per i suoi film e gli spettaco li teatrali, nonché per i tantissimi copioni scritti e diretti.
Quella foto parla di un Bergman insolito, per molti versi inedito, proprio come testimonia, riga dopo riga, il fondamentale volume-saggio di Leif Zern, il più autorevole e accreditato critico teatrale scandinavo e studioso del regista svedese, pubblicato meritoriamente ora in Italia. Si tratta della più importante biografia artistica, ma non solo, dell’uomo di teatro, di cinema e di televisione che, probabilmente più di qualunque altro cineasta, ha cambiato il nostro modo di guardare il mondo attraverso la relazione con gli altri (l’universo femminile, in particolare), di mostrarci il passato per capire il presente, di ‘vedere Bergman’ per scoprire nelle sue ossessioni, nelle sue fragilità, nei suoi incubi e nei suoi desideri raccontati senza veli, o reticenze, noi stessi.
Così, questo itinerario di Zern, nell’opera totale di Bergman, diventa per lo scrittore e il lettore una sorta di romanzo di formazione che segue, passo dopo passo, la straordinaria avventura artistica e umana di un genio del set cinematografico e della scena teatrale la arricchisce di fatti e di aneddoti curiosi, divertenti, mai banali, in un intreccio continuo di vita quotidiana ed esperienza artistica, necessario artigianato e persistenti problematiche filosofiche.
Non una riflessione organica su Bergman, ma uno studio complessivo fatto di lampi, intuizioni, di salti concettuali e temporali, per restituire, non la linearità di un percorso artistico, ma i frammenti, gli sbalzi, la devianza improvvisa, una particolare specie di creatività materiale.
Zombitudine: dal teatro al libro
A fine gennaio Zombitudine subisce una trasformazione, sarà disponibile per l’invasione delle librerie nel formato cartaceo e digitale.
La casa editrice Cue Press, specializzata nella pubblicazione di testi e saggi teatrali, ha infatti pubblicato il libro Zombitudine di Elvira Frosini e Daniele Timpano.
Un uomo e una donna sono rifugiati in un teatro insieme al pubblico. Qualcosa sta arrivando. La minaccia è là fuori ed il teatro è l’ultimo spazio di salvezza in cui rifugiarsi nell’attesa della loro venuta.
Sì, ma loro chi? Gli zombi? La morte? I rivoluzionari? Un evento che cambierà la storia? Non lo sappiamo. Non lo sa il pubblico e non lo sanno l’uomo e la donna, sul palco in logorante e beckettiana attesa.
Forse arrivano gli zombi, ma non sono esseri mostruosi. Siamo noi. Automi che si trascinano già morti lungo traiettorie claustrofobiche e obbligate, sui binari in decomposizione di questa società frenetica e insensata, dove pericolo e salvezza sono la stessa cosa e i vivi ed i defunti hanno lo stesso inutile afflato rivoluzionario.
Oltre alla drammaturgia dello spettacolo Zombitudine, il libro contiene una prefazione di Gianfranco Manfredi, cantautore e sceneggiatore di fumetti, tra gli altri, per Sergio Bonelli Editore; un saggio dello studioso Federico Boni, docente di Sociologia dei processi Culturali e Comunicativi alla Statale di Milano, e una postfazione di Daniela Ferrante, organizzatrice della Compagnia Frosini Timpano per la produzione del progetto Zombitudine.
«Che li si prenda singolarmente oppure in coppia, Elvira Frosini e Daniele Timpano sono fra le presenze più imprevedibili e provocatorie del teatro italiano di oggi: ogni loro intervento graffia, disturba, spiazza la sensibilità dello spettatore. Il loro nuovo spettacolo si intitola non a caso Zombitudine, e vuole assumere sarcasticamente la condizione dei morti-viventi come emblema dell’Italia di oggi, metafora di una fine collettiva, ma anche di una paradossale speranza di rinascita» (Renato Palazzi, «Il Sole 24 Ore»).
Collegamenti
Caldo
Nel percorso creativo dell’infaticabile Jon Fosse – puntellato di opere diventate fondamentali per la drammaturgia contemporanea, tradotte e rappresentate anche in Italia come Qualcuno arriverà, Sogno d’autunno, La ragazza sul divano – il testo Caldo (Varmt) aggiunge un altro prezioso tassello al processo di scarnificazione del linguaggio e della struttura dei personaggio proprio dell’autore.
La forza di questa opera presentata in prima mondiale al Deutsches Theater di Berlino nel 2005 per la regia di Jan Bosse e proposta in versione italiana al Teatro Tor Bella Monaca di Roma nel 2017 (regia di Alessandro Machia; con Alessandra Fallucchi, Giorgio Crisafi e Luca Mascolo), sta nella rinnovata rivisitazione delle lezioni di Pinter e Beckett, da sempre fondamentali fonti ispiratrici del drammaturgo norvegese.
Siamo nel minimalismo estremo che si concretizza in dialoghi brevi e strutturati su una struttura sintattica di poche parole lunghe come un respiro o un sospiro, tanto da animare «una parata di fotogrammi di esistenza che restano sospesi, quasi a sancire che esistere è più che stare […] che un divenire», scrive in merito Franco Perrelli nella preziosa introduzione (Jan Fosse e il dramma dell’attesa) al libro da lui stesso tradotto.
Eppure in questi continui silenzi calati in un’atmosfera rarefatta, dove l’andamento cronologico è disturbato dai capricci della memoria, i personaggi si manifestano nella loro dimensione di essere-non essere, rivelarsi e scomparire nel nulla. Alla paralisi delle loro non-azioni manca lo sfogo tragico. L’incontro-scontro tra passione e pudore come inizia, così finisce: dal nulla al nulla.
I protagonisti di Caldo sono Il primo uomo, Il secondo Uomo, Una donna. Forse sono due perché i due uomini, l’uno prossimo alla terza età e l’altro nella fase della giovinezza, si alternano e si intrecciano nei dialoghi con la figura femminile che è (o è stata) moglie di entrambi e dai quali ha avuto figli. Il luogo dell’incontro è un pontile, vicino al quale si trova una misteriosa casa dove si sono consumati gli amori e che nei dialoghi è spesso evocata per poi scomparire come una bolla di sapone, come il ricordo lontano di una mente lucida-confusa. Alla stessa maniera si dissolvono nel gioco vorticoso delle immagini altri segni connotativi: il costume da bagno della donna indossato in una calda e sensuale estate, le belle forme del suo corpo, i suoi capelli bagnati.
Nelle battute conclusive si sostanzia l’essenza poetica di Caldo:
«IL PRIMO UOMO Ma noi stiamo qui IL SECONDO UOMO Noi stiamo qui DONNA Qui dobbiamo stare noi IL SECONDO UOMO Forse IL PRIMO UOMO Noi dovremmo IL SECONDO UOMO Certo noi dobbiamo stare qui»Sono parole che evocano forme scheletriche di esistenza enigmatiche e significative. Forse la trasfigurazione delle nostre.
Collegamenti
Roland Schimmelpfennig. In un chiaro, gelido mattino
Il nome è molto difficile da pronunciare. E anche da ricordare. Ma bisogna farlo, questo sforzo, giacché Ronald Schimmelpfennig è sicuramente tra i massimi scrittori contemporanei tedeschi e non solo. Generazione 1967, originario di Göttingen e formatosi a Monaco, Schimmelpfennig è tra i drammaturghi viventi più rappresentati al mondo. La sua più importante messinscena italiana – nonché, che io sappia, l’unica – è del gennaio 2014, al Piccolo Teatro di Milano: Visita al padre, uno spettacolo magnifico con Paola Bigatto, Anna Bonaiuto, Caterina Carpio, Marco Foschi, Mariangela Granelli, Massimo Popolizio, Sara Putignano e Alice Torriani, nella regia profonda e intelligente di Carmelo Rifici.
Visita al padre è rimasto per cinque anni anche pressoché l’unico lavoro reperibile in italiano dell’autore tedesco (pubblicato da Cue Press): un testo nevrotico, quasi spastico, tutto incentrato sul tema della perdita. La trama è molto semplice, con echi archetipici: Heinrich, il padre, si è autoesiliato in una grande villa, circondato da quella che oggi si definirebbe una famiglia allargata: la moglie, la figlia, la figlia della moglie, la nipote, una congerie di donne tra cui il padre regna, tra estenuanti sessioni di cucina e una traduzione del Paradiso perduto di Milton a cui lavora da più di dieci anni. Una mattina bussa alla porta un ospite inaspettato: Peter, figlio di Heinrich nato da una dimenticata relazione giovanile, e da lui mai conosciuto. L’arrivo di Peter scatena una incontrollabile reazione di eventi a catena, che porteranno all’espulsione del figlio dal nucleo familiare, sancendo in maniera definitiva la sopraffazione dei padri nei confronti dei figli: ribadendo simbolicamente il diritto dei primi a detenere per sempre il possesso della casa e l’uso patriarcale delle donne presenti; con l’eccezione della giovane Isabel, che invece fugge via con Peter. I seguenti due capitoli della trilogia seguiranno proprio le vicende tragicomiche di questi due figli.
Visita al padre è un testo che come pochi altri affronta il tema della perdita: una perdita irrimediabile, consumatasi nel passaggio tra una generazione e l’altra: l’incapacità di una generazione a comunicare alla successiva qualcosa di fondamentale eppure mai esplicitato, forse proprio perché incomunicabile. Cosa? Un linguaggio, un modo d’intendere la sensualità, un significato, una nozione di ordine, un’identità, una disciplina, una forma. In Visita al padre questo vuoto di passaggio si verifica infatti tutto al livello della comunicazione. Lo si vede non solo nei contenuti ma anche nelle forme, nei modi con cui Schimmelpfennig utilizza le strutture teatrali: decostruendo, procedendo per frammenti e materiali, come nella migliore tradizione post-drammatica contemporanea soprattutto tedesca, ma conservando di quelle strutture scomposte proprio il grosso spessore tradizionale, la grana dura dell’archetipo: i richiami a Ibsen, a Cechov, a Brecht, insomma ai punti cardine del teatro della generazione dei ‘padri’. Chi siano poi questi padri, Schimmelpfennig sembra segnalarlo con inesorabile chiarezza: sono gli ultimi che hanno avuto contatto con chi ha fatto esperienza della guerra. Non è un dettaglio da poco. La villa di Heinrich è situata in un luogo la cui peculiarità è quella di essere stata teatro di moltissime guerre. Heinrich, il padre, il patriarca, non è solo il maschio alfa dominatore di una tribù di donne, ma è anche l’unico in famiglia a saper usare un’arma. Il padre è, qui, soprattutto colui che è ancora in grado di usare la forza. Il figlio, che invece non ha forza ma solo una stracca, distratta sensualità, non può far altro che capitolare, scappando via insieme a Isabel, l’altra figlia di Heinrich.
[…]
Collegamenti
«Il teatro è un coro del noi», il manifesto di Marco Martinelli
«Non si può bluffare se c’è una civiltà teatrale, perché il teatro è una grande forza civile, il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell’altro, dell’ignoto, della vita, della morte».
Lo immaginava così il teatro Leo De Berardinis in uno dei suoi tanti scritti sul cosa e come deve essere il teatro. Cosa e come: i due interrogativi che chi abita quel luogo mette in discussione continuamente, senza mai porre l’ultima parola. Il teatro è visione, costruzione di rapporti, di comunità. Il teatro è pena e antidoto, rivelazione dell’essere e costruzione del noi.
Il teatro è un fare. Un fare ben conosciuto a Marco Martinelli, regista e drammaturgo, poeta di compagnia del suo Teatro delle Albe di Ravenna, autore di Farsi Luogo. Varco al Teatro in 101 movimenti, presentato in una particolarissima lettura scenica sabato scorso al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia.
Animali a sangue caldo
Un Farsi Luogo che è quasi una partitura dell’anima, un manifesto per immaginare il teatro come luogo del visibile, del necessario, dell’utile. Un manifesto che, nella molteplicità di esempi e suggerimenti che vengono dall’esperienza diretta di trent’anni di lavoro in una delle compagnie più apprezzate del panorama italiano, mette le comunità del teatro sin da subito di fronte ad un dilemma: cosa fare? Cosa fare di un teatro che deve essere vivente, pulsante come un animale a sangue caldo? Cosa fare di un teatro che si illude del ‘possibile’, dei muscoli, dell’io, delle rivoluzioni umane e sociali ancora da innescare?
Martinelli risponde con un linguaggio narrativo e con parole costruite nei perimetri del suo modo di fare teatro, nella sua ‘spirale’ dove le pratiche e le idee sono già solide e pronte per contaminare e germogliare. Allora indica la strada: dalla mancanza di rivoluzioni («ogni epoca è buona per accendere una miccia») alla schiavitù del possibile, inaccettabile perché farsi luogo è, soprattutto, andare oltre il possibile. Una chiamata alle idee per costruire un noi solido, un riflesso di quell’io che si specchia negli occhi di una seconda persona che è l’essenziale, un coro da costruire che sia presente a quell’esercizio di cittadinanza che il teatro dovrebbe istituire.
Dal personale si passa al politico senza intravedere con chiarezza i limiti e i confini. Limiti sottilissimi, perché il teatro è ovunque e la politica e il teatro sono due modi di ‘mettere in vita’ la società. La vita invade la scena, ricorda più spesso il regista nei suoi punti sparsi nel libro.
Essere disarmati
La rivoluzione dentro di noi, l’esercizio di comunità, la spirale che si allarga per includere gli opposti della polis costituisce il legame del noi con la ‘materia sacra’ del teatro. Così diventa luogo dell’esplorazione dell’essere cittadino, spazio fisico della democrazia comune. In teatro bisogna essere disarmati: i muscoli si annullano, le armi non servono, le lingue si uniscono al coro comune, l’io è in penombra. Il meticciato non è un compromesso ma è una ‘felice condanna’, il migrare aiuta, la bellezza non è estetica ma è etica della bontà.
Il sottotitolo del libro, Varco al teatro in 101 movimenti, è molto eloquente. Marco Martinelli con questo pamphlet pubblicato dalla casa editrice di Mattia Visani (la prima casa editrice italiana dedicata alle arti dello spettacolo) cerca di scavare un varco, allargare una fessura aperta in un mondo ripiegato su se stesso. Scrive ripetutamente: «Più che la messa in scena mi interessa la messa in vita, un corto circuito, un legame infuocato tra gli artisti e i cittadini».
Teatro e anima
Alla base c’è questo messaggio: il teatro non rinnega la sua anima quando si preoccupa dei problemi che lo circondano, quando ingloba quel reale nelle sue mura mescolando vita e finzione, assieme mondi drammaturgici e vitali. Il teatro è luogo del fare quando si confronta con le contraddizioni della vita sociale. Si fa luogo quando affoga in questo campo indistinto. Il fondatore del Teatro delle Albe, conosciuto per la non-scuola e per quei due asini, simboli della compagnia, condannati ad ascoltare tutti i lamenti del mondo, ci ricorda che è un metodo da recuperare perché è stato sempre così, da Aristofane a Brecht: teatro e polis.
La scena e la vita, la finzione e la realtà. Una convivenza comune inscindibile: perché teatro è insieme sociale senza etichette. È un noi, è un coro da amplificare per ritrovare quell’io sono noi e recuperare una responsabilità politica comune per essere singolo nell’insieme.
Così, la narrazione di Martinelli diventa un manifesto sull’utilità del teatro come collante sociale, quasi un’ancora per salvarsi assieme dai mali comuni.
«Il Novecento che abbiamo alle spalle è un secolo monologante, riflesso di un solipsismo sempre più disperato, della perdita di identità nella società di massa, della perdita di che cosa significhi essere comunità. A me sembra che pensare il coro, oggi, agirlo al centro della scena, possa far ritornare i drammaturghi e registi alla questione politica per eccellenza, al legame di sangue del teatro con la società».
Collegamenti
L’irrefrenabile Savinio. Non solo musica e pittura. Visionario di una scena mitico-surrealista, scardinò il teatro borghese
Ad Alessandro Tinterri, che insegna Storia del teatro all’Università di Perugia, dobbiamo un libro fondamentale su Piandello capocomico, edito da Sellerio nel 1987, dove sono elencati, con relative distribuzioni, i cinquanta spettacoli realizzati al Teatro D’Arte, nelle Stagioni 1925-28, dove figurano autori come Massimo Bontempelli con Nostra Dea (22 aprile 1925), Alberto Savinio con La morte di Niobe (14 maggio 1925), Rosso di San Secondo con Marionette, che passione (29 giugno 1926).
Dei tre, Tinterri ha scelto di dedicare gran parte dei suoi studi a Savinio, curando, per Adelphi, i testi teatrali, i romanzi, le critiche raccolte in Palchetti romani, mentre con le edizioni del Mulino pubblicò una monografia (1993) che, in edizione riveduta e corretta, viene riproposta da Mattia Visani per Cue Press.
Anche questo fu, allora, un libro fondamentale, proprio perché c’era bisogno che qualcuno desse ordine a un autore un po’ disordinato come Savinio, la cui irrefrenabile fantasia spaziava tra generi diversi, ovvero tra musica, pittura, teatro, con incursioni nella scenografia e nella regia.
Per Tinterri, Savinio doveva ritenersi uomo di spettacolo, essendo, il palcoscenico, il luogo ideale dove potesse trovare approdo il suo multilinguismo. Tinterri si chiede, e me lo chiedo anch’io, perché la scena italiana, che pullula di autori improvvisati, non smetta di essere in ritardo su autori come Savinio, Rosso, Bontempelli, che costituiscono il meglio di quel periodo rivoluzionario che li vide muoversi con e attorno a Pirandello, con lo scopo di inserire il teatro italiano in una dimensione europea, contribuendo, non solo all’innovazione linguistica, ma anche scenica.
Per questi autori contava la parola, alla quale, specie per Savinio, spettava il compito di creare delle ‘visioni’ che l’attore doveva rivestire con voce e corpo. All’inizio del Novecento, si affermarono i movimenti avanguardistici, ai quali dette un contributo determinante il futurismo, un po’ meno D’Annunzio con i due Sogni, che tendevano, involontariamente, al simbolismo. Savinio, Rosso e Bontempelli, sotto la guida di Pirandello, cercarono di scardinare il teatro borghese, ma fu Savinio l’autore più avanguardista, avendo inserito la sua scrittura scenica in una dimensione mitico surrealista, tanto da mettere in crisi i suoi esecutori, come accadde a Strehler quando curò la regia di Alcesti di Samuele con attori non adatti a quel tipo di teatro, come Pilotto e la Brignone.
Tinterri ci racconta come e quando Savinio si era convertito al teatro, ma anche le vicissitudini di Capitano Ulisse, pronto per andare in scena al Teatro D’Arte, ma che dovette accontentarsi di una messinscena raffazzonata al Teatro degli Indipendenti di Bragaglia (1938) con la regia improvvisata di Nando Tamberlani. Bisognerà attendere il 1990, quando Pietro Carriglio, allora direttore del Biondo di Palermo, commissionò a Mario Missiroli la regia di Capitano Ulisse, che fu presentato come un vero e proprio classico, benché Missiroli si fosse lasciato prendere la mano, ricorrendo a generi diversi che, sul palcoscenico, fecero stridere alquanto.
Ne fummo testimoni io e lo stesso Tinterri. Sono, però, convinto che autori come Rosso, Bontempelli e Savinio, abbiano bisogno di grandi istituzioni teatrali o grandi compagnie per essere rappresentati. Lo capì Egisto Marcucci che con Emma B vedova Giocasta realizzò uno spettacolo esemplare, con Valeria Moriconi protagonista, con la quale realizzerà un altro testo, tratto da un racconto La nostra anima, che debuttò al Festival di Spoleto. Ma è giusto anche ricordare La partenza degli Argonauti, con la regia di Perlini e Il coturno e la ciabatta di Ida Omboni e Paolo Poli. Poi, il silenzio. Il volume di Tinterri potrebbe essere d’auspicio a nuove messinscene.
Collegamenti








