Logbook
Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

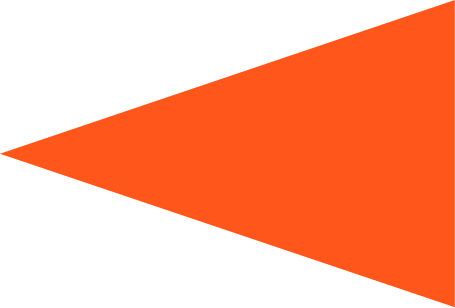
Il Neorealismo secondo Alberto Farassino
Il trentacinquesimo Bellaria Film Festival ha ricordato, nel maggio 2017, Alberto Farassino, promuovendo la ripubblicazione di quel prezioso libro-catalogo che nel 1989 accompagnò la retrospettiva Neorealismo. Cinema italiano 1945-1949, curata da Farassino con la collaborazione di Sara Cortellazzo per il Festival Internazionale Cinema Giovani di Torino.
Nella copertina dell’edizione originale, in bianco e nero, figura il dettaglio del volto di Anna Magnani, interprete di Il bandito (1946) di Alberto Lattuada, con una sigaretta in bocca. Un vivace tocco di rosso sul fotogramma, in corrispondenza dell’estremità accesa della sigaretta, attira lo sguardo e rende ancora più straniante una faccia già quasi irriconoscibile: quella dell’attrice senza le borse sotto gli occhi leggermente abbassati, con lunghe ciglia finte. Nel film di Lattuada la ‘diva’ neorealista gioca una parte molto lontana dall’icona della popolana che l’ha resa celebre un anno prima con Roma città aperta.
La scelta di quell’immagine truccata è già un segno dello sguardo innovativo e microscopico che Farassino intende ‘gettare’ sul Neorealismo, cercando di esplorare, al di là dei monumenti consacrati, le figure, le opere e gli spazi rimasti offuscati o controversi nelle varie visioni ufficiali che si sono succedute negli anni.
Ora sulla copertina della riedizione di Cue Press figura sempre la Magnani, ma in un’inquadratura di Roma città aperta, quando lancia un’occhiata di traverso al militare tedesco, poco prima della sua corsa dietro il camion che le porta via il promesso sposo. Corsa divenuta l’emblema più accreditato del Neorealismo: quasi un’immagine da francobollo, una sorta di ‘santino’ del cinema del dopoguerra.
Non voglio togliere alcun merito a questa riedizione che – per problemi finanziari, forse, o per pigrizia – ha steso, letteralmente, anche un velo di cataratta sull’atlante iconografico composto da Michele Mancini, il quale chiude i discorsi del libro-catalogo con una serie di fotogrammi rappresentativi delle varie dimensioni della vita quotidiana e dello spazio familiare e sociale durante il Neorealismo, mostrandoci mense e cibi, insegne sulle strade, graffiti sui muri, macerie e ricostruzioni, interni delle case, abiti, oggetti e vizi (come appunto la sigaretta), valigie e mezzi di trasporto, ecc.
Proponendo un mutamento di coordinate negli studi sul Neorealismo, Farassino lavora principalmente proprio su queste iconografie e topografie della cultura del Dopoguerra, mettendo in luce una molteplice serie di materiali inesplorati o poco conosciuti che comprendono immagini e discorsi, film ed echi della stampa popolare d’epoca. La retrospettiva torinese del 1989 pone accanto ai cosiddetti capolavori unanimemente riconosciuti della triade Rossellini, De Sica, Visconti e ai film consacrati di De Santis, Lattuada, Germi, Comencini e Zampa, una lunga lista di titoli in cui i segni del Neorealismo si depositano in impasti ibridi, dentro le vecchie dinamiche dei generi ereditati dall’epoca pre-bellica.
Ma cosa sono esattamente questi ‘segni’ del Neorealismo? Farassino li definisce tratti testuali, ovvero «strutture, isotopie e dinamiche che riflettono […] i fenomeni e i comportamenti più caratterizzanti del periodo». Tali tratti si trovano disseminati in una molteplicità di film del tutto dissimili e riguardano temi come la guerra, la resistenza, la vita individuale e sociale del dopoguerra, il lavoro, i problemi sociali, la corruzione, la criminalità, le condizioni dell’infanzia, la politica e lo spettacolo.
Il fulcro concettuale intorno a cui ruota l’analisi di Farassino è l’abbandono del vecchio paradigma storicista che ha contraddistinto i discorsi sul Neorealismo almeno fino alla mostra pesarese del 1974 in cui si tenta una prima revisione della mitica stagione del dopoguerra attraverso un coro di voci vecchie e nuove. Fra queste ultime compare anche quella del giovane Farassino che assieme agli amici e sodali del gruppo milanese Cinegramma (Francesco Casetti, Aldo Grasso e Tatti Sanguineti) propone, attraverso gli strumenti dello Strutturalismo, un nuovo modo di affrontare il rapporto tra il Neorealismo e il cinema prebellico. La conclusione a cui giunge il gruppo è un’idea di Neorealismo fondato sulla eterogeneità (a livello ideologico, produttivo, politico, tecnico, espressivo e critico), che comporta le contaminazioni tra i generi e i testi, l’abbandono del mito del purismo e del capolavoro, l’apertura moderna alle ricerche intermediali.
Una eco della ricerca collettiva di Cinegramma rimane, quindici anni dopo, nel libro-catalogo di Torino, a cui partecipano Aldo Grasso e Tatti Sanguineti, il quale firma anche la prefazione e la post-fazione dell’attuale riedizione, rievocando «la famigerata intervista» a Giulio Andreotti nell’estate del 1989, da cui partirà il suo lungo lavoro sull’onorevole democristiano, che si concretizzerà molti anni più tardi in due film di montaggio a lui dedicati.
Tra i quattro del gruppo, comunque, soltanto Farassino continuerà le ricerche sul Neorealismo, spostando sempre di più lo sguardo dai discorsi teorici alle analisi dei testi e delle condizioni materiali, culturali e sociali in cui prendono corpo. Nel libro-catalogo di Torino il suo saggio ha un titolo emblematico: Storia e geografia del Neorealismo. Attraverso la parola geografia egli identifica, in linea con le tendenze della storiografia francese delle Annales, una dimensione spaziale e materiale da contrapporre alle logiche temporali ed esclusive della visione storicista, che traccia un percorso lineare del Neorealismo, fissando un periodo di maturazione dell’‘evento’ accanto a un passato di anticipazioni e a un futuro di strascichi e riprese. Visto dalla prospettiva geografica, invece, il Neorealismo si configura come una sorta di atmosfera che circonda e si insinua, secondo differenti combinazioni, nei testi, nei discorsi, nei comportamenti, nell’immaginario collettivo di un’epoca.
È questa la ragione per cui Farassino contrappone al Neorealismo stretto e lungo della visione storicista (limitato a pochi capolavori e disteso lungo tutta la storia del cinema italiano) un Neorealismo corto e largo, che corrisponde al periodo 1945-1949. In questi anni, infatti, a suo giudizio, il Neorealismo si configura come «un affare di vita quotidiana» che permea i media e, insieme, l’esperienza individuale e sociale. Riprendendo la metafora scolastica del titolo del suo saggio (già utilizzata in campo letterario da un noto studio di Carlo Dionisotti, risalente alla seconda metà degli anni Sessanta) Farassino identifica il Neorealismo con una sorta di lingua nazionale: l’italiano del nostro cinema, attraverso cui passano i problemi identitari e la nuova cartografia del paese appena uscito dalla guerra.
Al privilegiamento dell’ottica spaziale su quella temporale e della sincronia sulla diacronia storicistica corrisponde l’adozione di un criterio quantitativo anziché qualitativo nella considerazione dei film, che rigetta l’idea di una mitica e mai raggiunta purezza neorealista, con il connesso paradigma dell’imprescindibile autorialità. Farassino unisce così le poche ‘opere neorealiste’, in linea con i principi di un ‘movimento’ spontaneo, che ancora non sono stati formalizzati dalla teoria, ai numerosissimi ‘film del Neorealismo’, in cui si sedimentano anche se in modo episodico i ‘tratti testuali’ neorealisti. Il panorama che ne deriva è quello di una eterogeneità che il Neorealismo tiene insieme con il marchio di un ‘prodotto d’epoca’, ‘qualcosa di analogo a uno stile di oggetti d’antiquariato’ che si dissemina su testi e discorsi fortemente diversi, finendo per ‘riguardare la vita di tutti’, nel suo continuo passaggio dai film alla realtà e dalla realtà ai film.
Questo circuito di rifrangenze e di corrispondenze si interrompe, secondo Farassino, intorno al 1948-1949, quando non a caso la parola Neorealismo entra in circolazione, cominciano le definizioni e le teorie del fenomeno, mutano gli assetti governativi, legislativi e industriali, iniziano a cambiare le condizioni di vita in Italia.
Attraverso una significativa analogia con il periodo preso in esame, Farassino decide, nel suo libro-catalogo, di rigettare le riletture teoriche, di abbattere la mitologia degli autori, di ricercare apporti che sfuggano all’istituzionalità del linguaggio critico, di dare spazio alle fonti più popolari e sconosciute. Il libro ricrea così, in linea con la visione ‘non aristocratica’ del Neorealismo che professa, uno spazio di esercitazione che non esclude la leggerezza, la provocazione, il gioco. Di qui nasce il piacere dei testi e delle fonti d’epoca, ma anche delle testimonianze di cineasti e non cineasti, italiani e stranieri, che aprono il volume e occupano infine la cornice conclusiva dedicata al Racconto dei nonni (De Santis, Lattuada, Lizzani, Mida e Gelosi della Lux Film). In mezzo a queste memorie e alle operazioni dei saggisti, che si muovono come immaginari cronisti immersi nel corpo e nella materia viva del passato, resta il sapore di tante microstorie ancora poco conosciute e in larga parte ancora da esplorare. Il discorso che Farassino formula nel 1989 rimane valido ancora oggi: tanti film, nomi, immagini, racconti attendono ancora di essere riportati alla luce e alla visibilità. Insomma, ci sono ancora spazi aperti nella lettura di un fenomeno su cui si è spesso ‘straparlato’, che costituisce un mythos e, insieme, un vulnus della nostra storia, non soltanto cinematografica.
Collegamenti
La Bibbia del teatro che racconta il nostro tempo
ll teatro postdrammatico, libro uscito e studiato in tutto il mondo (partendo dal 1999, tre le edizioni tedesche) dell’emerito professor Hans-Thies Lehmann, sta finalmente per comparire in Italia (la traduzione è di Sonia Antinori, uscita e presentazione a Roma a Short Theatre) con Cue Press, casa editrice digitale ideata dall’ex attore Mattia Visani nel 2014, specializzata nello spettacolo, Cue Press offre l’edizione digital oltre alla cartacea con l’intento di proporre novità, ma anche il recupero di testi illustri e dimenticati.
Questo volume di Lehmann – classe 1944, docente a Francoforte e altrove – studia quello specifico teatrale che va oltre il testo, si fa materia autonoma (per questioni di regia o altro) ed è una ricognizione delle nuove forme sceniche dagli anni Sessanta a oggi: un panorama dei mezzi estetici in divenire, con un’antologia di materiali tratti dalla pratica teatrale internazionale, vedi il lavoro di Heiner Müller e Bob Wilson (i cui destini si sono ora incrociati a Spoleto), Jan Fabre o il nostro Luca Ronconi che ha aperto le strade. Lehmann, presidente della società brechtiana (autore su cui ha molto scritto), specialista di teatro antico, fa il punto quindi sull’evoluzione del concetto di estetica del teatro e sui diversi suoi strumenti sempre di meno appartenenti all’era classica.
Cue, la parola inglese nel marchio Cue Press, significa battuta, attacco, suggerimento: la casa editrice fa ricorso anche alla piattaforma per intensificare il contatto col corpo teatrante del nostro paese, dove il palcoscenico vive un momento più vitale del cinema. Tra gli autori della casa: Attisani, Cruciani, Malcovati, Martinelli, Puppa, Spregelburd, Turroni, Zagarrio, Zorzi e Farassino, e altri per il cinema.
L’America di Elio De Capitani
Il saggio di Laura Mariani si dipana in un arco temporale che va dal 1953 al 2015 ripercorrendo analiticamente e criticamente il percorso artistico di Elio De Capitani attraverso la lettura delle sue più recenti messe in scena e interpretazioni che ne hanno segnato significativamente la carriera. Si tratta di un ardito e intelligente tentativo di raccontare la storia di un attore, di un grande attore, leggendone le presenze sceniche in un afflato non eminentemente emico ma aspirando a un più generale respiro etico. L’analisi non si limita quindi allo studio della figura critica di Elio De Capitani ma introduce temi più generali che attengono alle problematiche dell’essere attore oggi con riferimenti anche all’essere attore nel passato, nell’Ottocento. Dopo una rapida e necessaria contestualizzazione – gli esordi della carriera e i primi spettacoli – l’autrice si sofferma su quattro magistrali interpretazioni (l’avvocato Roy Cohn in Angels in America, 2007 e 2009; Richard Nixon in Frost/Richard Nixon, 2013; Willy Loman in Morte di un commesso viaggiatore, 2014; Silvio Berlusconi in Il Caimano, 2006) arricchite da sette interviste (13 aprile 2014 – 6 dicembre 2015), nella visione di una filosofia che afferma come lo studio dell’attore non possa «prescindere dalla persona del singolo artista» ma comporti «un rapporto con il presente e con il sociale che va oltre l’individuo» (p. 15).
Angels in America di Tony Kushner, «fantasia gay su temi nazionali», è un testo potente e suggestivo, con protagonista l’avvocato Roy Cohn, egocentrico, assetato di potere, a soli ventisei anni consulente della Commissione permanente di indagine senatoriale con presidente Joseph McCarthy, anticomunista viscerale, incarnazione vivente del «male, il più famoso cacciatore di streghe americano del dopoguerra». Nel suo lavoro sul personaggio, rileva Laura Mariani, De Capitani si è calato in un mondo di relazioni, non ha isolato il suo personaggio ma al contrario lo ha connesso con tutti gli altri cercando al contempo di interagire con essi per comprenderli e farsi comprendere, privilegiando la teatralità.
Rilevante è stato il lavoro di De Capitani sulla traduzione per rendere il testo più facilmente comprensibile e le battute più incisive, al fine di renderlo più ‘teatrale’. Si tratta di una visione precisa che tende a proporre i testi in un linguaggio immediatamente intuitivo quando, spesso, la traduzione tende invece ad appesantirlo per rispettare il tessuto originale, che ovviamente è frutto della cultura dell’autore. Laura Mariani affronta questo problema proponendo diversi esempi e sottolineando come gli interventi di De Capitani siano sempre stati rispettosi dell’originalità testuale in una visione scenica complessiva. Un esempio significativo mi pare possa essere tratto dalla sesta scena, quinta e ultima presenza di Roy Cohn, quando incontra David Schine. L’attore traduce il «because I love you» del testo originale con «perché ti amo» e non con «perché ti voglio bene», come ha tradotto Cervio Gualersi, ripetendo la battuta, «non ha i toni dolci che le didascalie in qualche punto suggerirebbero, caso mai lascia intravedere il crollo. […] la prima volta che l’ho improvvisata – dice l’attore – ho visto un terrore autentico nei suoi occhi , credo che [Giammarini] sia rimasto davvero spiazzato. Avendomi sempre considerato un eterosessuale tranquillo e magari un po’ fobico nei contatti fisici tra uomini, quando mi sono buttato su di lui e l’ho baciato veramente – un real french kiss voglio dire –, cogliendolo di sorpresa, ha avuto un vero shock. Poi è stato possibile ripetere quell’effetto, ma con l’intensità, con il panico totale di lui la prima volta. […] io lavoro sempre sui poli e sui passaggi rapidi da uno stato d’animo all’altro» (p. 50). Da questa filosofia attoriale traspare una nota interpretativa di grande rilevanza, e cioè la diversità dello stato d’animo emotivo risultante da un’azione improvvisata e un’azione strutturata. Diversità di emozione, dice De Capitani, che predilige costruire la sua recitazione su poli opposti, che gli permettono sfumature e bellezze recitative ottenute con il passaggio da un «sentimento all’altro», in modo da non cristallizzare le situazioni emotive in modelli statici. Elio De Capitani, che l’autrice avvicina a un grande attore dell’Ottocento, nella definizione che ne ha data Claudio Meldolesi, non costruisce i suoi personaggi partendo dalla psicologia, ma al contrario li struttura attingendo dalle battute e dalle situazioni e collegandoli simbioticamente con gli altri personaggi: si tratta, mi sia consentito il riferimento orientalista, di un rapporto che passa attraverso i corpi degli attori e gli spazi nei quali agiscono in una visione zeamiana. Per De Capitani il suo teatro «non è mai un teatro di quarta parete e non è mai un teatro epico, se non quando lo deve essere; è un teatro che sta a cavallo fra queste due dimensioni: quindi c’è una schizofrenia fortissima fra dentro e fuori, fra controllo e completo abbandono, fra l’immedesimazione totale dentro l’attimo e la capacità di governare questa immedesimazione, fra cerchio d’attenzione strettissimo – sul me stesso introspettivo […] – e il fatto che nei teatri grandi bisogna continuamente ricordarsi che c’è una galleria, il quart’ordine lassù, dove spesso stanno i giovani, il pubblico più nostro. Avviene tutto insieme, è questa la difficoltà, per cui il gesto è guidato da una serie di impulsi opposti che potrebbero produrre caos» (p. 57).
In Frost/Nixon di Peter Morgan, Elio De Capitani interpreta il presidente statunitense che concede un’intervista al giornalista televisivo Frost, interpretato dall’altro attore-regista della compagnia Ferdinando Bruni, minaccioso e introverso il primo, scanzonato e scettico il secondo. Nella costruzione del suo personaggio De Capitani ha lavorato sull’interiorità e sull’introspezione psicologica disegnando un personaggio a tutto tondo che «nel teatro all’antica avrebbe chiamato in causa il ruolo del tiranno e del padre nobile» (p. 69). Non ha cercato di imitare Richard Nixon ma ne ha portato in scena la volontà di potere, la sua abilità oratoria, è un avvocato, e ne ha rivestito la figura fisica psicologicamente, curando in un approccio poligenetico il rapporto con lo spazio nel quale agisce e anche con gli altri attori. Per rappresentare il potere De Capitani si è ispirato a Craxi, Berlusconi e Formigoni, tre personaggi diversi che tuttavia incarnano la brama e l’avidità egocentrica per il successo: «Io ho fatto un Nixon tra museo delle cere e Oriente, perché questo mi dava quell’impatto che il potere ha» (p. 79). Nella sua interpretazione, rileva Laura Mariani, si nota una grande attenzione al camminare e alla gestualità, scelta che lo avvicina molto a una visione orientale della recitazione, che molto spesso privilegia la gestualità rispetto alla parola, esprimendo con la prima anche sensazioni e stati psicologici che le parole non sarebbero in gardo di svelare. L’attenzione di De Capitani alla gestualità è indirizzata alla costruzione meticolosa degli aspetti psicologici di Nixon, che deve sedurre, deve avere un’aria presidenziale. Sostiene De Capitani: «Ogni testo richiede un equilibrio diverso, ogni autore ti propone lui stesso un materiale su cui lavorare. Chi lavora in maniera più libera, più decostruttiva, di qualunque autore può fare materia per un suo esperimento, un autore lo può rivoltare come un calzino. Io invece cerco di ricostruire la particolare novità di quell’autore, di renderla di nuovo incandescente; anche come regista mi adatto molto di più all’autore di quanto non lo tiri dalla mia parte, perché mi incuriosice anche costruire il personaggio autore nel mettere in scena un testo» (pp. 80-81). L’equilibrio tra esteriorità e interiorità diventa essenziale nella realizzazione di un personaggio al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche o psicologiche e renderlo simile a un manichino, a una caricatura. Al contrario bisogna ‘viverci dentro’, provare microemozioni necessitate dallo scorrere di scene frammentate, sostiene Laura Mariani, che rendono difficile raggiungere «un crescendo lineare».
Di rilevante interesse scentifico e critico mi paiono alcune considerazioni che l’autrice propone partendo dall’interpretazione del personaggio Nixon proposta da Elio De Capitani. E cioè il lavoro dell’autore sul testo, i dialoghi tra sé e sé, interiori, «muti e ossessivi» con i quali Tommaso Salvini si preparava a entrare in scena, come ha scritto Claudio Meldolesi, la necessità che il critico e lo storico si interroghino sulla cultura che produce lo spettacolo, in un necessario approccio antropologico; l’esigenza che ci si interroghi su tutto ciò che sta attorno a uno spettacolo, «il teatro in forma di libro» proposto da Ferdinando Taviani, che può essere esteso anche alla letteratura minore. «Il teatro raccontato può essere più appassionante di quello visto? Sì, può esserlo, perché il lavoro dell’attore contiene molte più cose di quelle che si vedono, anche se, alla fine, sono queste a contare e a entrare più vivamente nella memoria» (p. 86).
La regia e l’interpretazione di Willy Loman, protagonista di Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, sono stati per Elio De Capitani un ‘punto di approdo’ per la sua carriera. Per portare sulle scene Loman, Elio De Capitani ha svolto un lavoro di introspezione su sé stesso – considera quel personaggio il «suo manifesto dal punto di vista recitativo» – ha costruito un modello di doppia recitazione, utilizza il linguaggio della psicologia. Prima del personaggio è il testo che ritma e determina la recitazione, perché bisogna lavorare sulla psiche sia del personaggio che su quella dell’attore. La vita di ogni spettacolo si intreccia inevitabilmente con quella degli attori che lo rappresentano. L’autrice ha conversato e intervistato De Capitani guardando il video del Commesso viaggiatore: sezionando il testo, scena dopo scena, ne è risultato un interessante racconto che ha permesso di precisare non solo le sue esperienze interpretative relative a Willy Loman, ma anche visioni che attengono al mondo dell’arte interpretativa in generale. De Capitani dichiara di non usare il mimetismo per i personaggi che interpreta, non imita, non cerca stereotipi, ma al contrario tende a trascendere i personaggi per attingere a una dimensione più stridente, quasi evocativa, nel senso di renderne manifesti pregi e difetti senza manifestarli esteriormente, ma proponendoli emozionalmente. La parola va connessa al pensiero del personaggio, alla sua interiorità e non «alla continuità discorsiva del testo scritto».
«La preparazione di nessun attore di teatro può dirsi completa finché non ha fatto un film», ha detto Marlon Brando, e così è stato per Elio De Capitani grazie al Caimano di Nanni Moretti (p. 115), film nel quale ha interpretato il ruolo di Silvio Berlusconi. I tre personaggi Roy Cohn, Nixon e Berlusconi presentano singolari analogie perché, secondo De Capitani, manifestano i germi del vitalismo di destra, smania per il potere e nessuna remora per raggiungerlo. De Capitani, scrive Laura Mariani, ha una particolare abilità nell’imitare i personaggi che porta in scena, ma la sua non è un’imitazione pedissequa simile alla caricatura, ma parte dall’interno, entra nell’interiorità del personaggio e ne mette in risalto le strutture psicologiche, anche quelle dell’immaginario, come direbbe Durand. Nel film De Capitani imita Berlusconi senza imitarlo, «si è messo a disposizione della visione di Moretti», non si è identificato in un ‘metodo’, ma «mescolando le pratiche: Stanislavskij e Brecht, il lavoro sull’esteriorità e quello sull’interiorità, l’imitazione e la reviviscenza, l’osservazione della realtà e la memoria di esperienze teatrali proprie e altrui. A teatro la ripetizione e il furto servono come basi di partenza per creare la propria individualità artistica, gli scarti nascono da processi di accumulazione, vita e teatro si confondono nel corpo e nelle memoria dell’attore» (p. 122).
Nel capitolo conclusivo del suo saggio, Laura Mariani si chiede che attore sia De Capitani e si risponde caratterizzandolo, con le sue stesse parole, «attore sociale» o «primario», un attore che analizza nella sua interpretazione sia le parole del testo che la vita interiore dei personaggi in una visione antropologica e lo definisce un po’ comédien e un po’ acteur. Tra le ultime affermazioni del libro scelgo queste righe che mi paiono il più lucido e sincero riconoscimento dell’arte di Elio De Capitani: «Nessuno poteva aiutarmi di più a capire l’identità del teatro italiano nel suo zoccolo duro – dichiara Laura Mariani – costituito dal mestiere e dalla tradizione, quello che definisce una civiltà teatrale nazionale» (p. 132).
Concludendo, mi piace accostare L’America di De Capitani a un altro bellissimo libro di Laura Mariani, Ermanna Montanari. Fare-disfare-rifare nel Teatro delle Albe, entrambi dedicati a due grandissimi interpreti della scena italiana, volumi che idealmente tessono un filo sottile che analitcamente congiungono il grande attore ottocentesco ai grandi attori dell’oggi. Occasioni per parlare di attori ma anche per inoltrarsi nel terreno della teatrologia in generale con approfondimenti e suggestoni di rilevante pertinenza scientifca e critica. Raccontando di attori, Laura Mariani analizza i testi dei quali sono interpreti, li seziona e li connette con la koiné della quale sono espressioni. Lavoro minuzioso, puntiglioso e affascinante che impreziosisce il suo lavoro e lo rende un importante contributo per la storia e la conoscenza dell’arte dell’attore e del teatro italiano.
Collegamenti
Dietro il microscopio la curiosità del critico
Rileggere, a oltre trent’anni di distanza dalla prima edizione (La Casa Usher, 1983), il volume Al limite del teatro aiuta a ricordare che studioso di razza ed esegeta brillante dei nuovi fenomeni fosse già all’epoca il giovane Marco De Marinis. E per chi non l’avesse finora mai incrociato – un po’ difficile perché, o sui banchi prima dell’Università di Macerata (per pochi anni) e poi nella lunga militanza all’ateneo di Bologna, oppure attraverso il corpo a corpo con i suoi libri, chi si occupa di teatro è destinato a intercettare il suo pensiero – questa ripubblicazione da parte di Cue Press, impreziosita da una prefazione di Moni Ovadia, fa risaltare almeno una caratteristica del De Marinis studioso: la curiosità per tutto ciò che di nuovo si muove agitandosi sulla scena, qualità che non è mai fine a sé stessa, ma si intreccia con la lucidità delle analisi e la capacità di mettere in relazione necessaria cose e concetti. Insomma, De Marinis, già in questo, che è uno dei suoi primi scritti, dimostra di non aver mai abbracciato le novità con aprioristico entusiasmo, bensì fa trasparire la sua adesione solo dopo aver sottoposto l’oggetto all’analisi del microscopio storico-critico.
E così puntualmente accade in Al limite del teatro, il volume in cui l’autore si occupa in presa diretta di ciò che accade sulle scene dal 1973 al 1982, vale a dire gli anni in cui si odono ancora gli echi del Sessantotto e che pongono al loro centro la stagione creativa dei movimenti del Settantasette. È l’epoca in cui collettivo e partecipazione, teatro politico e decentramento, laboratorio e animazione erano le direttrici su cui si muoveva il lavoro dei giovani gruppi. Fenomeni che, probabilmente, in Italia non hanno avuto eguali, pur somigliando, nelle motivazioni e nelle modalità organizzative, al bisogno di fare teatro che si respira oggi. Ma la lettura del saggio è anche un monito per i giovani a non ripetere gli errori dei loro padri: quella stagione infatti durò pochissimo, travolta dalle spirali autodistruttive di spaccature e scissioni.
Racconti del grande attore di Mirella Schino
Quel periodo della storia del teatro italiano denominato del ‘Grande Attore’ ha inizio con le rappresentazioni della Compagnia Reale Sarda all’Esposizione Internazionale di Parigi del 1855. Le compagnie teatrali, in quella particolare temperie storica, erano solite appoggiarsi ad un attore di grande fama solitamente maschile, non necessariamente protagonista, per attrarre il proprio pubblico. Furono questi «interpreti di prima grandezza» a generare il teatro del Grande Attore.
Per i tipi di CUE (casa editrice italiana che si dedica alla produzione di libri che riguardano le arti e lo spettacolo) è uscito Racconti del grande attore della studiosa di Discipline dello spettacolo e docente presso l’Università di Roma Tre Mirella Schino. Un volume chiaro ma rigoroso nelle premesse e intrigante nel prosieguo che si avventura in una interessante analisi di quell’epoca del teatro italiano che ancora, forse, viene fraintesa, erroneamente interpretata. Schino scrive:
Per decenni, il teatro ottocentesco è stato guardato con gli occhi del teatro dominante, quello del Novecento. È stato giudicato sulla base di criteri, di sistemi di produzione, di valori che non gli erano propri. È stata persino dimenticata una verità evidente: che i capolavori teatrali della seconda metà dell’Ottocento, sono stati assai più spesso quelli creati dagli attori che non quelli degli scrittori.
Obiettivo del volume, dunque, entrare all’interno di questo sistema artistico per cercare di comprenderne a fondo le linee di trasmissione dell’esperienza, i meccanismi organizzativi profondi dello spettacolo, l’unità di misura di questo tipo di teatro «che nell’Ottocento non coincide con il singolo spettacolo, ma con insiemi più ampi, come il repertorio, il ruolo, o persino, nel caso di attori d’eccezione, la biografia artistica». Quello del Grande Attore, peraltro, si presenta come un fenomeno tipicamente italiano, nonostante all’interno di questa corrente vengano accolti numerosi nomi stranieri. Ed eccole, le celebrità che hanno incarnato l’essenza del teatro ottocentesco: August Iffland, Edmund Kean, Francoise-Joseph Talma, e poi Gustavo Modena, Rachel, Antonio Petito, Tommaso Salvini, Adelaide Ristori, Ernesto Rossi, Sarah Bernhardt, Henry Irving, Ellen Terry, Ermete Zacconi, Giovanni Grasso, Angelo Musco, Eleonora Duse.
Il libro di Mirella Schino prende le mosse dall’opera di tre studiosi italiani che del fenomeno oggetto del libro sono stati anche testimoni: Silvio D’Amico (1887-1955, critico e teorico del teatro italiano), Mario Apollonio (1901-1971, storico del teatro) e Vito Pandolfi (1917-1974, critico e regista italiano).
Nelle pagine successive, una serie di racconti e testimonianze che suggeriscono la misura esatta del fenomeno fornendo anche la cornice entro cui vanno inquadrati i vari protagonisti del teatro del Grande Attore: Rachel e la sua interpretazione della Fedra di Racine nel racconto di Charlotte Bronte, testimonianze di Colette, della stessa Eleonora Duse, dell’attore e regista Konstantin Stanislavskij. Ulteriori capitoli riguardano Tommaso Salvini e il suo rapporto con il personaggio shakespeariano di Otello, Henry Irving raccontato da Gordon Craig (1872-1966, regista teatrale e teorico della regia), Sarah Bernhardt, grande interprete di ruoli maschili e, ancora, Eleonora Duse.
Illuminante e avvincente, la lettura di questo volume che non può mancare nella biblioteca di ogni amante del teatro
Il Neorealismo è la lingua nazionale del nostro cinema
«Il Neorealismo è l’italiano del cinema, la lingua nazionale che forse non sappiamo più parlare, perché ormai la koinè europea o planetaria è più utile o obbligata. Ma è l’unica che si possa ancora studiare a scuola, l’unica che ci consenta di fare bella figura in società e che ci dia un’identità all’estero».
Così scriveva Alberto Farassino nel 1989, nel saggio introduttivo al volume da lui curato Neorealismo. Cinema italiano 1945-1949, che all’epoca uscì come catalogo del Festival Cinema Giovani di Torino, a fianco di un’ampia retrospettiva.
Tutti a scuola si intitolava quell’attualissimo saggio, «poiché il Neorealismo sembra una materia di scuola – scriveva Farassino – un sapere istituzionale che solo una scuola attardata come la nostra può non contemplare nelle discipline di insegnamento». A distanza di quasi trent’anni, quel fondamentale libro-catalogo con le voci, tra gli altri, di Michael Cimino, Werner Herzog, Andrzej Wajda, Giorgio Strehler, è stato appena rieditato (Cue Press, pag. 303, euro 24,99) con una nuova prefazione di Tatti Sanguineti. La presentazione è avvenuta al recente Festival di Bellaria, che è stato dedicato proprio a Farassino, a testimonianza di quanto restino vive le idee e la lezione di questo studioso scomparso nel pieno della maturità nel 2003, docente a Trieste per vent’anni e sempre più considerato uno dei più autorevoli critici italiani del dopoguerra.
Come osserva Gianni Rondolino nella premessa a quel volume, Farassino aveva la capacità di analizzare il cinema «con l’occhio rivolto contemporaneamente ai grandi film e a quelli minori, ai registi prestigiosi e ai mestieranti, alle questioni tecniche e a quelle produttive». Del Neorealismo, per esempio, Farassino fece emergere l’aspetto regionalistico fino ad allora trascurato, con film girati lontano da Roma e anche dalle nostre parti come Cuori senza frontiere, La città dolente e Donne senza nome. Ieri come oggi, sia l’uscita, sia la riedizione del libro risultano utilissime per cogliere la complessità, la continuità e l’attualità del nostro movimento cinematografico più importante e famoso. Ma nel 1989, alla fine di un decennio in cui il cinema italiano aveva visto il tramonto dei grandi autori, e che era stato dominato dai nuovi comici e da generi di ogni tipo, il Neorealismo sembrava un argomento «un poco velleitario, forse inutile, fuori moda», come osservava sempre Rondolino.
Farassino invece ribadiva quanto esso non appartenesse solo agli anni Quaranta, ma fosse «un fenomeno per così dire eterno, una costante ricorrente dell’espressività cinematografica italiana». È la teoria del ‘fiume carsico’, la vocazione realistica del nostro cinema che dopo gli anni del muto riemerge prepotente nel dopoguerra ed è destinata a riemergere ancora, come nei primi anni Sessanta e come accadde alla fine degli anni Ottanta con film di svolta quali Mery per sempre di Marco Risi o Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.
E come aveva previsto Farassino, il ‘fiume carsico’ del Neorealismo riemerge ancora oggi. L’occasione può essere per esempio il quarantennale della morte di Roberto Rossellini, il regista del film capostipite, Roma città aperta, girato nell’estate del 1945 tra le macerie. Così vengono ora ripubblicate anche le memorie di Rossellini in Il mio dopoguerra, a cura di Goffredo Fofi (Edizioni dell’Asino, pag. 67, euro 8). E al padre del Neorealismo saranno dedicati due incontri domani e sabato, rispettivamente al Festival di Pesaro e al Cinema Ritrovato di Bologna.
Ma soprattutto, nelle sale italiane e nei festival internazionali, proprio nell’attuale stagione orfana degli incassi di Checco Zalone, troviamo un pugno di registi ostinati che resistono al disimpegno e descrivono gli umili e le periferie, personaggi dolenti e ambienti degradati. Che «lavano i panni sporchi in casa», come imputava al Neorealismo il giovane sottosegretario Giulio Andreotti nel 1948. Ecco allora, appena applauditi a Cannes, Fortunata di Sergio Castellitto, Cuori puri di Roberto De Paolis e L’intrusa di Leonardo Di Costanzo. Il primo racconta di una parrucchiera (Jasmine Trinca) della periferia romana e del suo coraggio, gli altri scavano in storie aspre e relazioni umane brucianti. In precedenza Daniele Vicari ci aveva mostrato, in Sole cuore amore, la barista Eli (Isabella Ragonese) con marito disoccupato e tre figli, che attraversa Roma facendo enormi sacrifici. Dice di questa ragazza lo stesso Vicari: «Eli è un personaggio neorealista».
Il corpo-mente di chi recita
«Il teatro raccontato può essere più appassionante di quello visto? Sì, può esserlo, perché il lavoro dell’attore contiene molte più cose di quelle che si vedono».
Scrive Laura Mariani nel suo studio sulle interpretazioni di Elio De Capitani in Angels in America, Frost/Nixon, Morte di un commesso viaggiatore (e nel film Il Caimano dove l’attore incarna Berlusconi, personaggio vicino al mito americano del successo e del potere).
Attraverso un interprete esemplare, l’autrice ci propone un racconto a più voci sulla pratica di lavoro di ogni attore: oltre alle parole del protagonista (interviste, scritti, persino un lungo sms) emergono testimonianze, memorie, considerazioni critiche di una miriade di attori, da Sarah Bernhardt a Gino Cervi, da Rina Morelli ad Al Pacino, presenze rese necessarie dall’accurata ricerca storica sui testi e sui loro allestimenti. De Capitani stesso rende conto del movimento caotico, intuitivo, che caratterizza la prassi dell’interpretazione, nelle cui suggestioni e stratificazioni compaiono attori del passato e del presente, del cinema e del teatro, pronti a fornire modelli a cui accostarsi o da cui prendere le distanze.
Intenzione dichiarata dell’autrice, quella di «ritrovare nel presente l’attore italiano, la solidità del suo mestiere, la capacità di raccontare storie», e di analizzare il lavoro dell’interpretazione, «come se entrassimo nel corpo-mente di chi recita». È impresa ardua raccontare il percorso di un interprete, poichè si tratta di «individuare e descrivere gli spazi di creazione autonoma in rapporto al testo e alla regia»; inoltre, De Capitani testimonia una varietà di approccio e una libertà di avvicinamento ai diversi personaggi che va al di là delle metodologie (e quindi delle terminologie) teatrali codificate, dai maestri russi fino allo Lee Strasberg del cinema americano: anche in sede di tecniche attoriche torniamo alla relazione proposta dal titolo del saggio, ossia quella tra un attore italiano e la cultura teatrale americana. E tra gli elementi ‘di tradizione’ dell’attore italiano, ampio spazio è dedicato all’eterno corpo a corpo con la nostra lingua. A tal proposito, De Capitani sottolinea i suoi ‘litigi’ con le traduzioni, in un senso inconsueto rispetto all’approccio letterario al problema: l’attore deve costruire un percorso di biunivoca relazione tra parole e immagine, sempre da verificarsi in scena, in rapporto cioè all’atto fisico del dire e alla organicità con gli altri segni.
Tramite il lavoro di De Capitani, inoltre, siamo condotti all’interno della storia del Teatro dell’Elfo (e di quarant’anni di teatro italiano) da cui emergono sia la magmatica – e non scontata – capacità di integrare forze giovani, sia il gruppo dei fondatori e collaboratori storici (Ferdinando Bruni, Cristina Crippa e Ida Marinelli) nel loro continuo e dialettico scambio di ruoli, attorale e registico. Da qui un’attualissima riflessione su queste due funzioni, la cui ridefinizione è cruciale: De Capitani si presenta infatti come ‘neo-interprete’, un attore cioè che continua a lavorare in termini di personaggio e di situazioni drammatiche, ma essendosi misurato a livello teorico e pratico con le novità della regia novecentesca. E Laura Mariani, in un ritratto riassuntivo, delinea un modello possibile dell’attore del futuro: drammaturgo, regista, organizzatore, vicino per sensibilità al professionista ottocentesco ma capace di rilanciare mestiere e tradizione a partire dalla relazione con il pubblico di oggi.
Come è cambiato il teatro secondo De Marinis
Un altro titolo non soltanto per gli addetti ai lavori, ma anche per gli appassionati di teatro, è stato appena ripubblicato da Cue Press. La casa editrice imolese, fondata e diretta da Mattia Visani, ha infatti recentemente messo sul mercato Al limite del teatro. Utopie, progetti e aporie nella ricerca teatrale degli anni Sessanta e Settanta, testo di Marco De Marinis, uno dei più importanti esegeti del cosiddetto ‘nuovo teatro’, oltre a essere un maestro per generazioni di studenti universitari. La pubblicazione rientra nel progetto editoriale di riproposizione della nuova teatrologia italiana, cioè di libri fuori commercio che ormai sono dei classici (la prima edizione di Al limite del teatro uscì con La Casa Usher).
De Marinis, così, d’impatto, cosa ricorda di quella stagione?
L’esplosione del teatro di gruppo, un fenomeno giovanile gigantesco che non ha avuto eguali.
Il teatro di quegli anni era una forma di identità collettiva. Oggi cosa resta?
Molto, non tanto sul piano delle estetiche e dei modelli, bensì sul duplice livello delle motivazioni e delle modalità organizzative. Oggi, in condizioni meno favorevoli per la creazione, molti giovani si dedicano al teatro, scegliendolo come stile di vita, per dare spazio e corpo alle inquietudini giovanili.
Quel periodo fu anche segnato da spirali autodistruttive…
Certamente le divisioni e le spaccature nei gruppi fecero sì che quella stagione durasse pochissimo e fosse effimera. Era un teatro di cultura e pedagogia, così quando si trattò di passare alla produzione molti non ebbero gli strumenti e sopravvissero in pochi.
Qual è l’attuale situazione a Bologna?
Non la possiamo scindere da quella della regione, che continua a essere estremamente ricca di realtà teatrali, condizione determinata soprattutto dai gruppi romagnoli. Bologna è stata meno feconda. Indubbiamente ospita molti attori interessanti, ma la presenza di teatri storici ingombranti ha forse impedito che si consolidassero realtà alternative. Con due importanti eccezioni: il Teatrino delle Moline al tempo di Luigi Gozzi e la presenza di Leo De Berardinis, dal 1983 al 2001, che ha prodotto capolavori e una nuova leva di attori; per la loro attività e funzione oggi vanno segnalati i Teatri di Vita e l’Itc di San Lazzaro.
1918: lezioni di teatro
Una splendida e impareggiabile (per capacità di sintesi storica e finezza culturale) introduzione di Fausto Malcovati ci racconta l’anno cruciale della Rivoluzione d’Ottobre (Russia, 1917) soprattutto nei suoi fondamentali risvolti teatrali, contestualizzando le quattordici lezioni di teatro di Mejerchol’d (giugno 1918 – marzo 1919), terminate con quella dal titolo profetico Il teatro del futuro è un teatro povero. Pagine ricche di intuizioni straordinarie, dense di riflessioni e di problemi, a distanza di quasi un secolo, tuttora aperti. L’indubbia importanza del libro si fa perdonare un vistoso refuso nel titolo del saggio malcovatiano: Mejerchol’d 1977. Esagerato!








