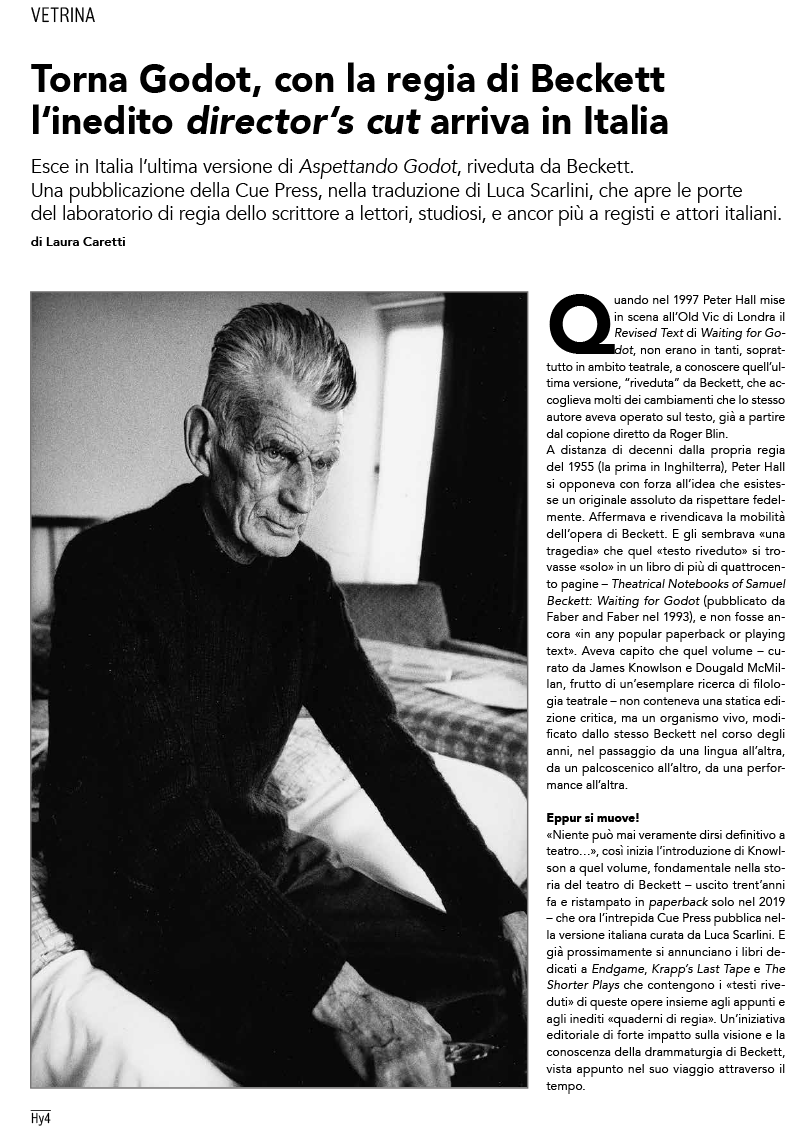Torna Godot, con la regia di Beckett l’inedito director’s cut arriva in Italia
Laura Caretti, «Hystrio»
Esce in Italia l’ultima versione di Aspettando Godot, riveduta da Beckett. Una pubblicazione della Cue Press, nella traduzione di Luca Scarlini, che apre le porte del laboratorio di regia dello scrittore a lettori, studiosi, e ancor più a registi e attori italiani.
Quando nel 1997 Peter Hall mise in scena all’Old Vic di Londra il Revised Text di Waiting for Godot, non erano in tanti, soprattutto in ambito teatrale, a conoscere quell’ultima versione, «riveduta» da Beckett, che accoglieva molti dei cambiamenti che lo stesso autore aveva operato sul testo, già a partire dal copione diretto da Roger Blin.
A distanza di decenni dalla propria regia del 1955 (la prima in Inghilterra), Peter Hall si opponeva con forza all’idea che esistesse un originale assoluto da rispettare fedelmente. Affermava e rivendicava la mobilità dell’opera di Beckett. E gli sembrava «una tragedia» che quel «testo riveduto» si trovasse «solo» in un libro di più di quattrocento pagine – Theatrical Notebooks of Samuel Beckett: Waiting for Godot (pubblicato da Faber and Faber nel 1993), e non fosse ancora «in any popular paperback or playing text». Aveva capito che quel volume – curato da James Knowlson e Dougald McMillan, frutto di un’esemplare ricerca di filologia teatrale – non conteneva una statica edizione critica, ma un organismo vivo, modificato dallo stesso Beckett nel corso degli anni, nel passaggio da una lingua all’altra, da un palcoscenico all’altro, da una performance all’altra.
Eppur si muove!
«Niente può mai veramente dirsi definitivo a teatro…», così inizia l’introduzione di Knowlson a quel volume, fondamentale nella storia del teatro di Beckett – uscito trent’anni fa e ristampato in paperback solo nel 2019 – che ora l’intrepida Cue Press pubblica nella versione italiana curata da Luca Scarlini. E già prossimamente si annunciano i libri dedicati a Endgame, Krapp’s Last Tape e The Shorter Plays che contengono i «testi riveduti» di queste opere insieme agli appunti e agli inediti «quaderni di regia». Un’iniziativa editoriale di forte impatto sulla visione e la conoscenza della drammaturgia di Beckett, vista appunto nel suo viaggio attraverso il tempo.
Ma non solo! Come nel caso di Peter Hall e di altri registi, questi «testi riveduti» possono diventare copioni di nuove messinscene anche in Italia. Rappresentano infatti l’ultima fase della creazione di Beckett, ritessuta dai curatori, James Knowlson e Stanley Gontarski, sulla base di una lunga ricerca fatta in costante dialogo con l’autore. «Beckett ha avuto un ruolo attivo in ogni decisione riguardo a quale testo usare, cosa includere e cosa escludere – mi scrive Knowlson –. Ho avuto la fortuna di essere sempre in contatto con lui per lettera, incontrandolo regolarmente, e anche assistendo in sua compagnia agli spettacoli. È stato vitale consultarlo. I testi sono come voleva che venissero presentati». E sappiamo, leggendo la premessa di Gontarski al volume di Endgame, come Beckett sia stato coinvolto nel ‛progetto’, generoso del suo tempo, pronto a mettere a disposizione i suoi appunti, e poi a suggerire, correggere, e «revisionare» la stesura finale per la pubblicazione. Fondamentale dunque vedere questi libri nella prospettiva della partecipazione attiva dello scrittore, e della sua volontà di stampare quelle sue opere, iscritte nella loro storia pregressa, come fosse la placenta che le ha nutrite. I Revised Texts sono infatti un punto di approdo: eccezionali composizioni in cui le varianti, messe in evidenza, mostrano la duttilità della sua drammaturgia quando si fa scrittura scenica. Sfogliandone le pagine, i segni tipografici invitano a scoprire i suoi interventi, le aggiunte, i tagli… E se le modifiche nelle battute appaiono meno frequenti (ma sempre emblematiche), le didascalie svelano la visione che Beckett ha della scena: i personaggi si animano, i loro corpi si materializzano, e ne vediamo i gesti, le azioni, i movimenti…
In Aspettando Godot, sentiamo più forte la solitudine di Didi e Gogo, e insieme l’urgenza vitale di tenersi uniti, secondo un’alternanza prossemica di allontanamenti e ricongiunzioni che risponde al loro ritmo esistenziale. Impossibile pensare che siano piccoli ritocchi! Ogni volta si scopre che anche il minimo cambiamento agisce su tutta la partitura orchestrata da Beckett.
Così accade subito nella metamorfosi visiva dell’inizio, con la presenza di Vladimir (prima messo fuori scena) e ora in piedi, «nell’ombra» vicino all’albero, che «ascolta» Estragon, piegato su se stesso, seduto su un «sasso» (il low mound è diventato stone passando per il tedesco stein, mentre era pierre nel francese, e di conseguenza pietra in italiano). In questa breve ouverture ci sono già alcune delle innovazioni che percorrono la revisione del testo: il «lungo silenzio» che tende e dilata l’attesa, la simbiosi di Didi con l’albero e di Gogo con il sasso, l’immobilità che sospende l’azione e crea degli improvvisi tableaux vivants: una trama di segni, che possiamo decifrare in tutta la loro polivalenza di senso con l’aiuto dell’apparato di note che accompagna questo testo riveduto. Qui si dispiega la ricerca compiuta sulle diverse edizioni di Aspettando Godot (in francese, inglese e tedesco), sugli appunti manoscritti, aggiunti in margine ai testi stampati, sui copioni delle regie dirette in prima persona (allo Schiller Theater di Berlino nel 1975, e con il San Quentin Drama Workshop nel 1984), su quelli a cui ha solo collaborato e soprattutto sui suoi «quaderni di regia».
Il quaderno rosso: Godot Berlin 1975 II
Nella seconda parte del volume, la stampa in copia anastatica del secondo di questi Production Notebooks apre le porte del laboratorio di regia di Beckett: una copertina rossa (su cui si legge: Godot Berlin 1975 II) fa da sipario alle 109 pagine a quadretti con gli appunti manoscritti, sia prepara- tori che presi durante le prove, della sua regia di Warten auf Godot allo Schiller Theater di Berlino, quando lo scrittore entra nel vivo del processo di messinscena. I cambiamenti fatti in precedenza, ora confluiscono in una revisione radicale del testo.
La traduzione tedesca si modifica e, in una solitaria, personalissima, rilettura anatomica di tutta l’opera, Beckett prefigura il passaggio alla scena. Ecco cosa si trova in questo quaderno, e l’emozione è indescrivibile. Ogni pagina una rivelazione! Scopriamo l’ossatura delle scansioni interne, le sequenze correlate, i temi ricorrenti, i punti d’attesa… Vediamo muoversi i personaggi su sintetici diagrammi; sentiamo risuonare più volte le stesse battute, le richieste di aiuto, le canzoni.Verso la fine si illuminano le luci. E appare l’albero con «due rami soltanto» – non tre («non era giusto», scrive) – e «due foglie», con l’ultima folgorante spiegazione: «Terza coppia».
Aspettando un nuovo Godot…
Sappiamo che a Berlino questa immagine non fu realizzata. Arriva quindi attraverso il tempo a chi voglia portarla in scena. Questo libro è infatti anche una miniera di idee di regia. Come scriveva Knowlson nella premessa – fatta propria dalla redazione italiana – i «testi riveduti», gli appunti, i quaderni di regia di Beckett non intendono limitare «la libertà» dei registi. Ognuno si regolerà secondo la propria «visione artistica».
Aspettiamo dunque di vedere cosa succederà sulle nostre scene. Intanto si sa che sono state fatte due traduzioni di questo ultimo Waiting for Godot. Una inedita, non autorizzata dagli eredi di Beckett e rifiutata dall’editore, di Angelo Romagnoli, tesa a cogliere la musicalità e il ritmo della partitura vocale e scenica di Beckett. E quella, con la traduzione pubblicata in questo volume, di Luca Scarlini, che affronta in presa diretta «l’enorme complessità» di questo testo, mirando a innovare la tradizione italiana. «Ho voluto veramente partire da zero – mi dice –, dimenticando per quanto possibile la versione classica di Carlo Fruttero che avevo in mente, e cercando di seguire il testo revisionato nei suoi numerosi cambiamenti, nelle sue numerose varianti. Avevo letto anni fa questo volume, ma non con l’approfondimento che ora mi ha permesso di entrare nel meccanismo di cambiamento che Beckett aveva agito, quando a Berlino aveva cominciato effettivamente a maneggiare la scena». Una nuova lettura di Beckett che ci auguriamo contribuisca a far rivedere questo nuovo Godot anche in Italia, a settant’anni dalla sua nascita in Francia.